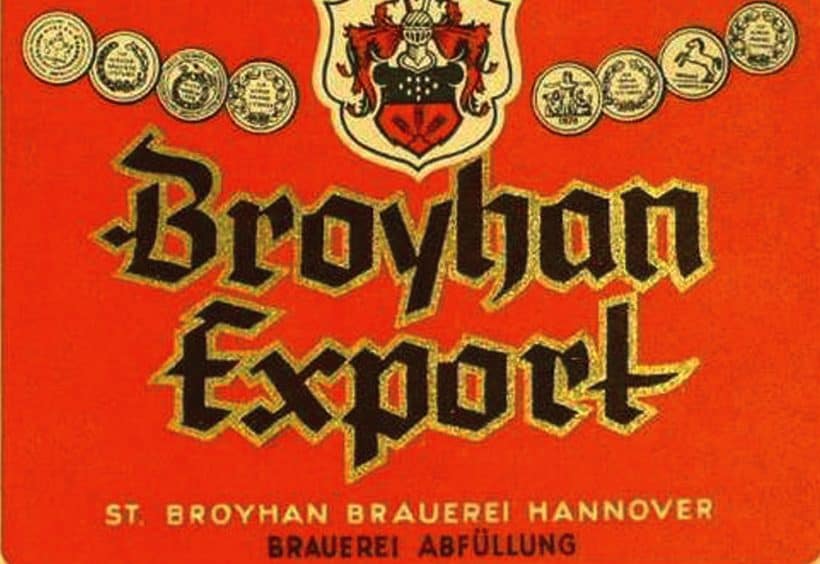Stili da riscoprire: le tipologie a rischio estinzione
È sterminata la mole di tradizioni, denominazioni più o meno specifiche, varianti locali e stili (il cui concetto, come sappiamo, è molto moderno e si riconosce unanimemente a Michael Jackson) narrati e riportati dagli storici della birra nel corso dei secoli fino ai giorni nostri. Molte birre sono ormai defunte ma tante altre sono sopravvissute e vengono tuttora riproposte o reinterpretati. Del resto è anche grazie a loro se il mondo birrario riesce sempre a sorprendere e rinnovarsi.
GERMANIA
Iniziamo il nostro viaggio alla ricerca delle birre dimenticate e fortunatamente recuperate, dallo scenario tedesco. Dove troviamo, anzitutto, un paio di tipologie che si è provveduto a riscoprire ormai da qualche anno anche in Italia: Grodziskie e Lichtenhainer. La Grodziskie (o Grätzer, anche se di appartenenza più polacca che tedesca) è un’affumicata ad alta fermentazione, ottenuta da solo frumento maltato ed essiccato al legno di quercia. Fiore all’occhiello della città di Grodzisk, oggi in Polonia, questa chiara (dal paglierino al dorato) di bassa gradazione (2.5-3.3% circa) e dal gusto dolceacidulo (derivato dal grano) è talvolta percepita come produzione di scuola teutonica in virtù delle vicende politiche di Grodzisk stessa, che dal 1793 al 1920 venne a trovarsi entro i confini della Prussia tedesca, con il toponimo di Grätz.
Quanto alla Lichtenhainer, essa stessa deve il proprio battesimo alla località d’origine, Lichtenhain, oggi un quartiere di Jena, in Turingia. Una alta dai fondamentali leggeri (colore dal paglierino al dorato, gradazione 3.5-4.7% circa), che esibisce timbriche rauch, apportate da malto d’orzo in parte affumicato); caratterizzata dal gusto acido in ragione di un intervento fermentativo da parte di lattobacilli (non però in caldaia o in fermentazione primaria, come nelle Gose o nelle Berliner Weisse, bensì in secondaria o in maturazione).
Non ancora avvistate in Italia sono invece la Roggenbier, la Broyhan e la Mumme. Partiamo da quest’ultima: siamo in Bassa Sassonia, a Brunswick; qui, dal 2008, ha ripreso vita la tradizione medievale delle Braunschweiger Mumme, così battezzata (è un’ipotesi) dal tardo-latino mumia (mummia), con riferimento alla propria capacità di conservazione. Prodotta con malti d’orzo, segale e avena, rivela un aspetto opalescente, aromi fenolico-fruttati e un rinfrescante gusto dolceacidulo.
Rimanendo in Bassa Sassonia, è Hannover il tempio delle Broyhan, birre in scena dal 1526 e tra le dominatrici del panorama tedesco settentrionale per 200 anni, prima di essere spazzate via dallo tsunami-Lager. Devono il proprio nome a quello dell’ideatore, Cord Broyhan. Quanto al profilo procedurale e sensoriale, occorre raccogliere le tessere di un puzzle per niente univoco. Di certo in miscela secca si usavano malto di frumento e d’orzo, più talvolta d’avena: e in generale è molto probabile che si macinasse ciò che si aveva. Di certo la gradazione era leggera (spesso sotto il 3%), la luppolatura era modesta (se non assente) ed era praticata (facoltativamente) l’aggiunta di spezie e radici. Quasi sicuramente il processo subiva fisiologiche batterizzazioni, ricercate anche in alcune ricostruzioni odierne mediante acidificazione da batteri lattici.
Spostiamoci dalla Bassa all’Alta Sassonia per conoscere la Zerbster Bitterbier: birra dai malti affumicati su insolito legno di ontano e ancora non nitidamente ricostruita, ma sicuramente scura, intensa e dalla decisa verve luppolata. Scendendo in Baviera è Ratisbona la culla delle Regensburger Roggenbier: per farla brutalmente breve, una Hefeweizen con alte percentuali (fino a quota 65) di segale (in tedesco, appunto, Roggen) sotto forma di malto. Colore dal ramato al bruno chiaro, aspetto velato, schiuma ampia, gradazione sul 4.5-6%) profumi (fenolico-fruttati) e palato (dolceacidulo) non dissimili da quelli di altre specialità di frumento, la Roggen si distingue per il lieve finale piccante, tannico e amaricato.
Un gruppo ulteriore di stili abita poi in riserve territoriali circoscritte. Il primo, in Baviera, è quello delle Nürnberger Rotbier, letteralmente le Rosse di Norimberga. Attestate fin dal medioevo, addirittura con un disciplinare del 1303, sono birre elaborate a bassa che devono la propria designazione a un mosto impostato su un solo tipo di malto, il Rotes Spezialmalz. Si aggiunga una luppolatura da varietà classiche tedesche e si avrà qualcosa di intermedio tra una Vienna e una Märzen.
Sempre in Baviera, ma un poco a sud, nel circondario di Augusta, la località di Altenmünster tiene alta la bandiera delle Steinbier, che spiccano per il carattere affumicato, attinto mediante una procedura assai peculiare. Il mosto, lavorato a bassa, viene infatti scottato calandovi pietre arroventate al fuoco di legna (fino a 1.200 gradi), che cristallizzano parte degli zuccheri sulla propria superficie; e che, una volta raffreddate, vengono rimosse per poi tornare nella massa liquida in maturazione. Così facendo la CO2 sviluppata asporta lo zucchero caramellato, portatore di un’impronta dolce-bruciata. Il colore della birra è bronzeo, la schiuma beige, gradazione e corporatura di medio tenore.
Ancora in Baviera, ma nel lembo sud-orientale del Land (al confine con la Repubblica Ceca) troviamo le Dampfbier: in estrema sintesi un incrocio tra Weissbier e Märzen. Storicamente, si tratta di una alta, preparata appunto con lieviti da Weizen, inoculati però in un mosto di solo malto d’orzo (essiccato a temperature da tostatura) e fatti lavorare in barili di legno dai quali, in virtù del calore fermentativo, risalivano sbuffi di CO2 in colonne simili a getti di vapore (in tedesco, appunto, Dampf). Gli aromi sono vicini a quelli di una Hefeweissbier; la gradazione sui 5 gradi; l’assetto gustativo dolceacidulo con un vezzo amaricante nel finale.
Balzando in Nordreno-Vestfalia, a Düsseldorf ecco due varianti maggiorate (in alcol, colore, tostature e luppolature da amaro) della Altbier: oltre i 5.5 gradi assume il nome di Sticke (termine che sembra significare segreto); se punta e sfora gli 8 passa al rango di Doppelsticke. Mentre a Dortmund – che ha dato i natali anche alle Dortmunder Export (sull’orlo dell’estinzione), dal caratteristico tocco minerale su base maltata molto amaricata – l’Adambier è tra quegli stili che si è provato a recuperare, ma mai perfettamente riemersi. La caratterizzano malti scuri, spunti acidi, passaggi in botte, certe fattezze affumicate e una gradazione spesso oltre il 10%: un matrimonio di sensazioni complicate da materializzare in un’unica piacevole esperienza.
Ugualmente bizzarra ma più sensata la combinazione di peculiarità che si riscontrava nelle birre di Cottbus (siamo nel Brandeburgo), dove ormai appare chiaro come in quell’area, a ridosso della Polonia, ci fosse un’alta concentrazione di fermentazioni agli antipodi delle Lager. Le Kottbusser, per esempio, erano chiare di grado contenuto (sul 4.5%), che vedevano l’impiego rigoroso di luppolo (a differenza delle Broyhan), a partire da un variegato grist di malto d’orzo, frumento, avena, zucchero e miele. Dotate di spiccata acidità lattica, tanto che Cottbus era un riferimento, fino a due secoli fa, per la fornitura dei fermenti diretti a Berlino per produrre le più note Berliner Weisse.
EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
A corollario della Germania, stabiliamo questa seconda area d’osservazione, pur molto ampia, in quanto – tra l’altro – contrassegnata, Paese per Paese, da varianti locali di tipologie della scuola tedesca.
In Austria incontriamo le Abzug, sorta di versione Session delle Vienna, e le Österreicher Märzen, che rispetto alle bavaresi sono più chiare, più leggere (5-5.5 i gradi) e di gusto sempre maltato, ma con un maggior spazio per il luppolo.
In Polonia da poco riscoperte ci sono le Schöps, birre di frumento ad alta fermentazione (ma con lieviti rigorosamente neutri), sui 6-7 gradi, tipiche di Breslavia, declinate in colorazioni dal dorato leggero all’ambrato scuro, con note maltate (biscotto, caramello) e un notevole slancio dato dal grano maltato (usato in quota che sfiorava l’80%). Parzialmente nebulose la conoscenze circa le Danziger, alcoliche di alta fermentazione prodotte con consistenti dosi di zenzero, coriandolo e quel ginepro che per tradizione tipicamente baltica che si incarna anche nella città portuale di Danzica. Da menzionare, poi, le Marcowe, corrispettivo delle Marzen (con gradazioni sul 5-6% e con varianti affumicate); le Kozlak, vicine alle Dunkles Bock, ma di alcolicità cauta (baricentro sul 6.5%) e di caramellatura più pronunciata (ammiccante alle Doppelbock).
Lo zig-zag ci porta in Repubblica Ceca, dove troviamo le Vidensky (aggettivo che significa viennese e che allude a una traslazione, sostanzialmente tal quale, in territorio boemo, dello stile brevettato da Dreher); dall’altro le Pšeničné Pivo o Pšeničné Kvasnicov, locuzioni che traducono, rispettivamente, quelle di Weizenbier e di Hefeweizenbier. Infatti per quest’ultime il malto di frumento non è inferiore al 30% (l’indicazione di un limite minimo è tra le non molte differenze rispetto al protocollo monacense); il colore è chiaro e l’aroma di timbro fruttato-fenolico. Inoltre, per scrupolo di completezza, ricordiamo come, nel Paese di San Venceslao, le basse fermentazioni più diffuse – legalmente classificate in Světlé (chiare), Polotmavé (ambrate), Tmavé (scure) e Černé (nere) – mostrano evidenti attinenze con lo schema cromatico in cui rientrano Helles, Vienna/Marzen e Schwarzbier, differenziandosi però per lo spettro fermentativo.
PAESI BASSI E BELGIO
L’ulteriore tappa della nostra ricognizione ci conduce nei Paesi Bassi storici: quella porzione di territorio europeo che, dal 1830, è divisa tra Belgio e Olanda. È su quest’ultima (formalmente il Regno dei Paesi Bassi) che posiamo per prima la nostra attenzione. Qui troviamo alcuni stili tradizionali tuttora vivi, sebbene con un limitato numero d’interpretazioni.
Come la Venlo, espressione della città omonima (nella provincia del Limburgo) e stilisticamente plasmata sul modello delle non distanti Altbier di Düsseldorf, da cui si discosta per il colore più chiaro, il gusto meno tostato, una tendenza all’acidificazione sul calco Flemish, la possibilità di aggiungere frutta, specie fichi e uvetta. Poi la Kuit o Koite o Koyt, dominatrice del proscenio nazionale tra fine ’300 e ’700, nata da un protocollo che prevede dosi contenute di luppolo, fermentazione ad alta, un mosto di avena, frumento e orzo (nelle proporzioni rispettive di tre, due e una quota). Ulteriore rarità battente la bandiera orange è poi quella della Dutch Oud Bruin, da non confondere con la Vlaams Oud Bruin: mentre infatti la fiamminga spicca tra le più note rappresentanti del fronte sour ale, le olandesi sono a bassa, di color mogano, di gradazione castigata (2.5-3.5%) e integrate con dolcificanti onde apportare spessore a un’architettura sensoriale altrimenti al minimo.
Scendiamo ora in Belgio. Qui una tipologia recuperata e resa oggetto di esecuzioni contemporanee anche ben oltre i confini nazionali è la Grisette, tipologia sorta nello Hainaut di fine ’800, in transizione da comprensorio prevalentemente agricolo a distretto estrattivo e carbonifero. Se i lavoratori dei campi avevano avuto da sempre la loro birra (la Saison), quelli delle miniere invece ne erano sprovvisti. Esigendo una bevuta facile, dissetante e da assumere in robuste quantità, verrà cucito loro su misura un prodotto di bassa gradazione (3-5%), di colore dal paglierino all’ambra, di lieve corporatura e dalla vocazione rinfrescante. Per realizzarlo si affidavano non tanto ad acidificazioni controllate o a frumenti crudi, ma piuttosto a un apporto significativo di luppolo in caldaia. Riguardo al profilo sensoriale odierno, però, non pochi produttori scelgono di curvare la rispettiva Grisette in direzione sour o wild. Quanto all’appellativo Grisette, ricalca quello delle ragazze, vestite di grigio (gris, in francese), incaricate di portare birra appunto ai minatori, all’uscita dai pozzi.
Oltre alle Wit o Blanche (e alle più robuste Dubbel Wit o Double Blanche rinvigoritesi qualche decennio fa e caratterizzate da maggiore sostegno e compattezza dei cereali, nonché di contributo alcolico, a parità di ingredienti e di speziatura), molte erano le birre al frumento per cui il Belgio era noto: come le Peeterman, variazione ambrata su telaio alcolico non indifferente (anche 7%), talvolta addizionate di gesso per favorire l’imbrunimento in cottura. L’abbondanza di diversi cereali permise la proliferazione di birre come le Seefbier, realizzate coi classici orzo e frumento, l’intrusione dell’avena, più la presenza speciale di segale e grano saraceno. Birra molto opalescente, non presentava contaminazioni lattiche e la sua scomparsa risale un secolo fa, nell’ambito di un’operazione in seguito alla quale oggi questa designazione risulta un marchio registrato di Antwerpse Brouw Compagnie. Sempre la città dei diamanti è la culla delle poco considerate Spèciale Belge, alte, ambrate e rotonde, cugine belghe delle inglesi bitter, caratterizzate da lievito in grado di generare esteri e rotondità tali da interagire con la luppolatura britannica e distinguendosi con un fuorviante appellativo informale di Belgian Pale Ale (oggi pericolosamente travisabile). Tra le tante tipologie che non ce l’hanno fatta fortunatamente si tirano fuori anche le Bière d’Orge des Flandres o Uytzet, semplicissime Session Ale con moderna luppolatura anglosassone (tra le tante tipologie che compongono l’appellativo generico Bière de Table).
GRAN BRETAGNA
Se nell’Europa continentale il novero degli stili resuscitati si rivela particolarmente copioso, anche oltremanica il tema risulta non del tutto a secco di argomenti. In primo luogo per la prosecuzione, in Scozia, di un’esperienza come quella riguardante ricette in cui si fa largo uso di elementi botanici: un costume (risalente fino a millenni prima di Cristo) di matrice celtica e rituale, in virtù della quale ci concediamo la licenza di adottare la dicitura di Druidic Beers. Stiamo parlando di birre dove trovano posto a fini di conservazione e aromatizzazione, erbe amaricanti ed essenze vegetali o floreali di vario genere, come olmaria, erica, mirto e ginestra, aghi d’abete e bacche di sambuco.
Dal nord del Regno Unito procediamo alle sue coste occidentali, per far luce, in Galles, sulla tradizione delle Welsh Ales. Qui la birrificazione è attestata fin dall’800 d.C. e testi quali l’opera annalistica Anglo-Saxon Chronicle, riferiscono, già alla metà del IX secolo, una distinzione tra Fine Ales (leggere) e Welsh Ales, chiamate Bragawd o Braggot: in realtà qualcosa a metà strada tra una birra in senso stretto e un Mead, antica bevanda ottenuta dalla fermentazione di miele e altri ingredienti, come cereali, frutta, luppolo e spezie. La tradizione britannica, cresciuta e consolidatasi nei secoli, ha perso per strada diversi pezzi, attraverso mutamenti industriali e commerciali. Il caso più eclatante è forse quello dell Burton Ale, una strong di successo in epoca vittoriana, popolarissima a Burton-on-Trent tanto da invadere il mercato londinese e perfino dominare le rotte baltiche per la Russia. Evolvendosi, ha partorito da un lato le luppolate IPA, dall’altro i Barley Wine, fino a piazzarsi su un segmento intermedio (5-7.5 gradi) e morire a fine anni ’70, probabilmente a causa delle sue stesse caratteristiche. L’acqua di Burton, nota per le alte concentrazioni di solfati e bicarbonati, rendeva la birra assai spinta sull’amaro da luppolo, sebbene spesso bilanciato con una buona dolcezza maltata.
SCANDINAVIA, BALTICO E RUSSIA
Altro settore geografico di ampie dimensioni adatto a essere trattato unitariamente, in virtù della presenza, trasversale ai Paesi e alle regioni che lo compongono, di attitudini procedurali in parte affini tra loro. Si tratta di usanze sedimentatesi in tipologie che non si sono mai perdute, e che continuano a esistere in una bolla isolata. Partiamo dalla Russia e dall’Europa Orientale ex sovietica, dove troviamo una tradizione, molto antica, che si trova a essere oggetto di numerose esecuzioni moderne. Si tratta del Kvass, un fermentato dalle origini medioevali, pensato dai contadini che lo preparavano essenzialmente ammollando in acqua del pane raffermo: pane prodotto con farine di grani scuri (come frumento integrale e segale), sebbene il canone consuetudinario ammettesse ingredienti ulteriori, quali barbabietole e miele. Quanto alla conversione in alcol (prodotto comunque in quantità assai basse, attorno allo 0.5%), vi si provvedeva in tini aperti, mediante fermentazioni condotte da batteri lattici e lieviti del genere Saccharomyces. Così, accanto alla gradazione dietetica (benché oggi si lavori in modo da attingere responsi etilici sul 4%), il Kvass presenta valori di acidità più o meno pronunciati e gode tuttora di ampio consumo.
Dalla Russia alla Norvegia, terra di fiordi, ma anche di foreste, patria di birre affumicate. Quantomeno, un simile epiteto spetta di diritto al comprensorio della città di Stjørdal, che, insieme al vicino villaggio di Hegra, costituisce la culla di uno stile brassicolo denominato, alternativamente (a seconda che ci si trovi nell’uno o nell’altro de due centri abitati), Stjørdalsøl o Hegra Maltøl. Al di là del campanile, la stessa tipologia, elaborata seguendo le medesime regole d’ingaggio: parte del malto essiccato lentamente (per 15 o 20 ore) ai vapori generati da un fuoco di legna di ontano; einlaug, ovvero acqua portata a ebollizione con rami di ginepro; fermentazione con lieviti ad alta.
Lo stesso ginepro, poi, è il passaporto che agevola in transito nella vicina Finlandia. Essa stessa uno scrigno di storia birraria, alla quale appartiene la tradizione del Sahti. Bevanda millenaria, si ottiene – originariamente per inoculo di lieviti da panetteria, ai giorni nostri normali ceppi da Ales – lavorando su un mosto di cereali maltati o meno (orzo, segale, frumento e avena), quando non dalla fermentazione di pani preparati con quegli ingredienti. Il quale mosto, di norma non bollito, viene incisivamente aromatizzato, oggi anche con luppolo, ma nelle versioni tradizionali con bacche di ginepro: la filtrazione prefermentativa avviene infatti a contatto coi rami di questa pianta, attraverso un condotto tubolare detto kuurna. Il Sahti è probabilmente da considerare come una tra le diverse espressioni specifiche di una medesima inclinazione produttiva, comune all’area scandinavo-baltica, nella quale la specialità finnica trova almeno due tipologie sorelle, il Gotlandsdricke e il Koduõlu. In Svezia, il Gotlandsdricke deve il proprio nome all’isola che gli ha dato i natali, quella di Gotland, e, in sintesi, ricalca le caratteristiche (di preparazione e sensoriali) proprie appunto del Sahti, salvo (secondo alcune fonti) discostarsene per un più sistematicamente ricorrente tono di affumicatura. In Estonia, invece, si ha modo d’incontrare il Koduõlu, la cui procedura di lavorazione, patrimonio dell’isola di Saarema, prevede l’impiego di lievito da panificazione.
Intanto, però, con l’approdo estone, si è messo piede nel perimetro (comprendente anche Lettonia e Lituania) delle Repubbliche Baltiche: il quale, unitamente all’intera Scandinavia, condivide quello che non costituisce uno stile birrario, bensì una categoria procedurale, trasversale a una molteplicità di differenti stili storici. È la famiglia delle Raw Ales, che deve tale epiteto a una peculiarità di evidente rilievo: il mosto, prima della fermentazione (sempre Alta, le Lager sono escluse dal tema), non viene sottoposto a bollitura. Circostanza, questa, che stando al punto di vista di alcuni osservatori, divide in due, come uno spartiacque, la genealogia stessa di singole tipologie, che dovrebbero essere ripartite in due sottoclassi, in funzione del passaggio o meno del mosto in caldaia.
Dare conto di tale consuetudine era indispensabile, prima di poter affrontare il resto del quadrante baltico; in particolare per quanto riguarda la Lituania, dove i costumi brassicoli locali si sono conservati con una specificità che si concretizza in una serie piuttosto ampia di birre tipiche. Partiamo dalla loro matriarca, la Kaimiškas, termine che significa rurale, e che identifica in realtà più che un solo stile, una famiglia di sottostili. I loro comuni denominatori coincidono con alcune tecniche tenacemente tradizionali: l’uso di ingredienti quali malti autoprodotti; l’inoculo di ceppi di fermenti da colture di proprietà della casa; l’aggiunta di luppoli selvatici autoctoni; la fermentazione in tino aperto a temperature tra i 29 e i 35 °C; la rinuncia alla filtrazione e alla pastorizzazione. Quanto ai tratti sensoriali essenziali mediamente si è in presenza di colori tra l’ambrato e lo scuro, di gradazioni tra il 5 e il 7%, di carbonazioni decisamente esili.
Autentica scheggia di archeologia birraria vivente è poi la Keptinis, i cui esempi odierni si attestano in media tra i 5 e i 6 gradi, ma la cui taglia in origine gravitava attorno a valori probabilmente più bassi, in virtù delle peculiarità della lavorazione. Si parte da una miscela di cereali maltati (orzo, avena e forasacco, in proporzioni variabili), irrorata con acqua calda e sagomata in panetti, o in grossi piastroni; i quali (con spessori tra i 17 e i 19 centimetri) vengono infornati su strati di paglia, cotti per qualche decina di minuti fino ad assumere un colore tra il sughero e il bruno, per poi essere triturati con pestello e mortaio, onde ammostarli insieme al luppolo (in quantità o a discrezione) e a corteccia o fiori di tiglio. La massa liquida riposa per 4-5 ore (coperta così da mantenersi tiepida), non viene sottoposta a bollitura, ed è consegnata invece tal quale alla fermentazione, totalmente aperta o con inoculo di colture ad hoc. Il risultato? Tinte fra il rossiccio e il mogano; lineamenti gustolfattivi dolci-aciduli (cospicuo è il contenuto di destrine, non spiccatissima l’acidità, sebbene una vena lattica possa crescere col tempo); corporatura sostanziosa.
Temperamento oscillante esibisce invece la Šviesusis. D’altronde il pacchetto dei suoi minimi denominatori produttivi (malto locale essiccato a bassa temperatura e lievito idem autoctono; confezionamento di norma non filtrato) si trova declinato tanto in bassa quanto in alta fermentazione. Al netto di ciò, elemento identificante è una certa impronta barnyard (aia, cortile e ambienti confinanti), un timbro connesso evidentemente alle colture di microorganismi in gioco. Per il resto, questa specialità lituana è contraddistinta dal colore chiaro (il suo nome equivale all’inglese Pale), dall’aspetto velato, dal gusto abboccato, da aromi che interessano le aree del terroso, del panificato a breve cottura, della paglia, dell’erbaceo e del floreale, da sporcizie agresti quali non infrequenti note di ossidazione e percettibili livelli di diacetile. Infine, versione bruna della stessa Šviesusis è la Tamsusis (termine traducibile esattamente come scura), che oltre ai tratti un po’ ruspanti appena passati in rassegna, presenta tonalità nasali tostate (panificato dolce a lunga cottura, nocciola) e fruttate (bacche di bosco), nonché una curvatura gustativa incline decisamente alla dolcezza.
Alcuni produttori delle aree dal nord-est dell’Europa fino agli USA, stanno provando a ridare linfa a queste usanze, alcuni lavorando i lieviti kveik in modo tradizionale (lunghe bolliture e fermentazioni fulminanti), mentre altri facendo rivivere colture ignote fino a poco fa e eventuali intrusioni batteriche per dare vita a un filone alternativo di Kveik Pale Ale. Tempi brevi di fermentazione, interazioni intriganti tra lieviti e forsennati dry hopping, contribuiscono a tenere alto l’interesse per birre storiche oggi incredibilmente integrate nel patrimonio birrario mondiale.
AMERICHE, AUSTRALIA E AFRICA
Chiudiamo il nostro giro del mondo con un rapido volo fuori dall’Europa. Primo scalo in Australia, dove sopravvivono le Sparkling Ales: nate nel XIX secolo come contromossa, in replica ai competitori della madrepatria e alle loro Pale Ales, operata da parte dei produttori locali. Questi ultimi, in difficoltà per via degli scarsi risultati (in specie per la mancanza di un’adeguata diffusione di efficaci strumenti per la refrigerazione artificiale), optarono per una birra più fresca, facilmente e velocemente bevibile: più chiara, tra il dorato e l’ambrato leggero (quindi spostata verso il panificato appena cotto, anziché verso sensazioni tostate); più secca, grazie all’azione attenuante dei ceppi di lievito sviluppatisi localmente su colture inglesi; più vivace in virtù della maggiore carbonazione (la quale, tra l’altro, riusciva utile a limitare anche possibili minacce di deterioramento). Interessante anche l’evoluzione dello stile in ordine al luppolo: tradizionalmente preparato con Cluster (americano) e Goldings (inglese), è passato, negli anni Sessanta del ’900, a gettate di indigeno Pride of Ringwood.
Un salto ad attraversare il Pacifico ed eccoci in America: nel Nord del continente, per cominciare, dove troviamo ricostruzioni facenti capo alle cosiddette Spruce Beers, elaborate durante i decenni della colonizzazione. Nell’attuale Ontario, infatti, avendo constatato l’uso, da parte della tribù degli Uroni, di consumare una bevanda (sorta di tè) aromatizzata con corteccia di cedro bianco, e avendone apprezzato le qualità salutari, i primi europei insediatisi in quelle aree (nel XVI secolo), trassero spunto per preparare birre arricchite con abete (in particolare il peccio mariano), pianta più efficace nel garantire quegli apporti di vitamina C che erano decisivi per combattere lo scorbuto, patologia tipica proprio dei lunghi viaggi e delle conseguenti insufficienze alimentari. Nel tempo, poi, come accompagnatrice dell’abete sarebbe divenuta canonica la melassa: tanto in Canada, quanto nelle colonie lungo la costa est e dunque, successivamente, negli Stati Uniti.
Molte sono le varianti di stili europei brassati nel nuovo mondo, tra cui oltre alle note Cream Ale e Steam Beer sicuramente ci sono le Kentucky Common. Di base a Louisville, questa birra da circa 4% vedeva l’aggiunta di mais fino al 35% con qualche malto caramello ad arricchire la bevuta, tendenzialmente dolce ma scattante. Sembrano quasi la versione ambrata di una Cream Ale, ugualmente di basso costo produttivo, fermentata da un vorace ceppo ad alta fermentazione che la rendeva pronta in pochissimi giorni, motivo per cui difficilmente si dirigeva verso una deriva acida, come a volte erroneamente reinterpretato.

Come per il resto della storia, alcune produzioni autoctone precoloniali non sono mai state incluse dall’industria birraria americana e lo stesso vale per Sud America e Africa. Salve per miracolo, ma solo nelle tradizioni popolari per cui non commerciali, la peruviana Chicha (birra di mais ammostato tramite gli enzimi della saliva umana) e la sudafricana Umqombothi (birra di mais e sorgo).