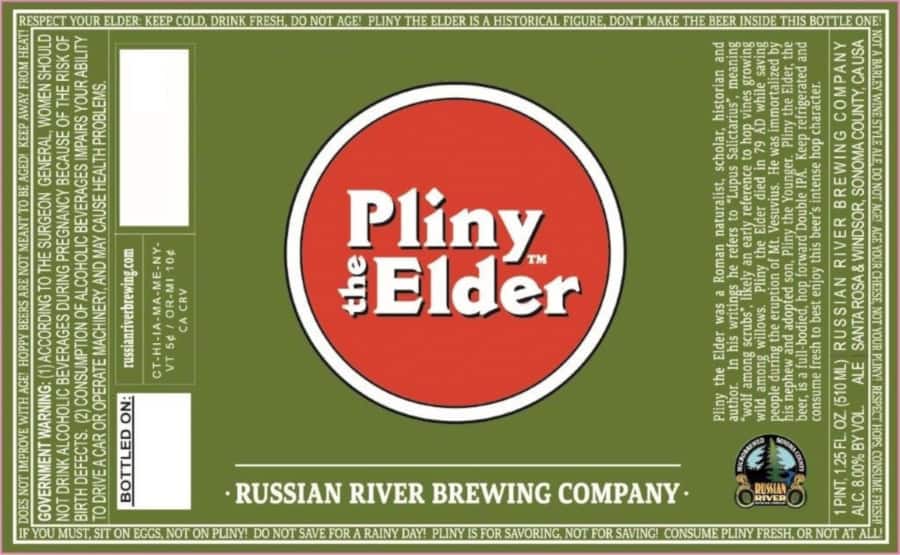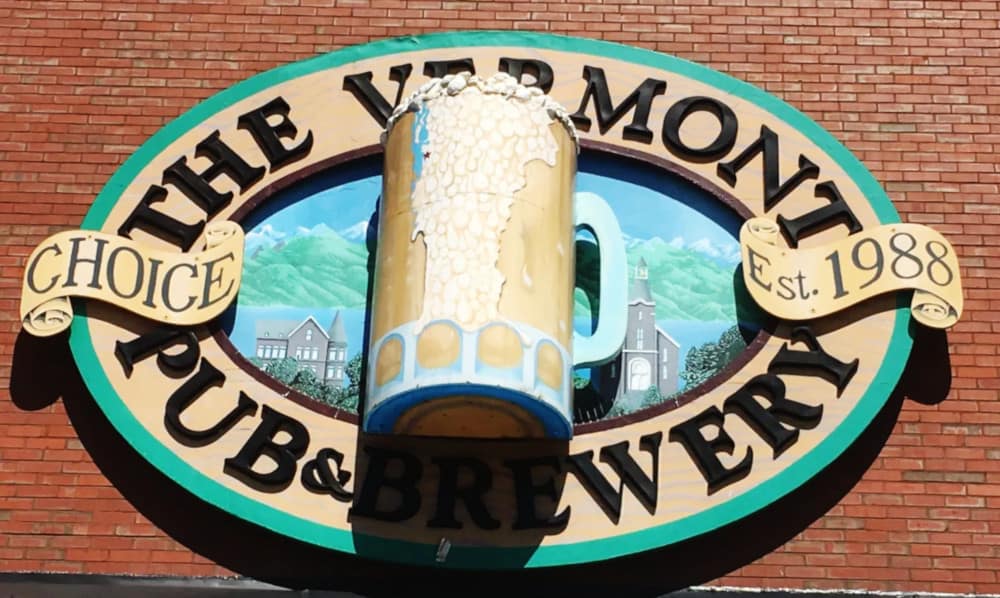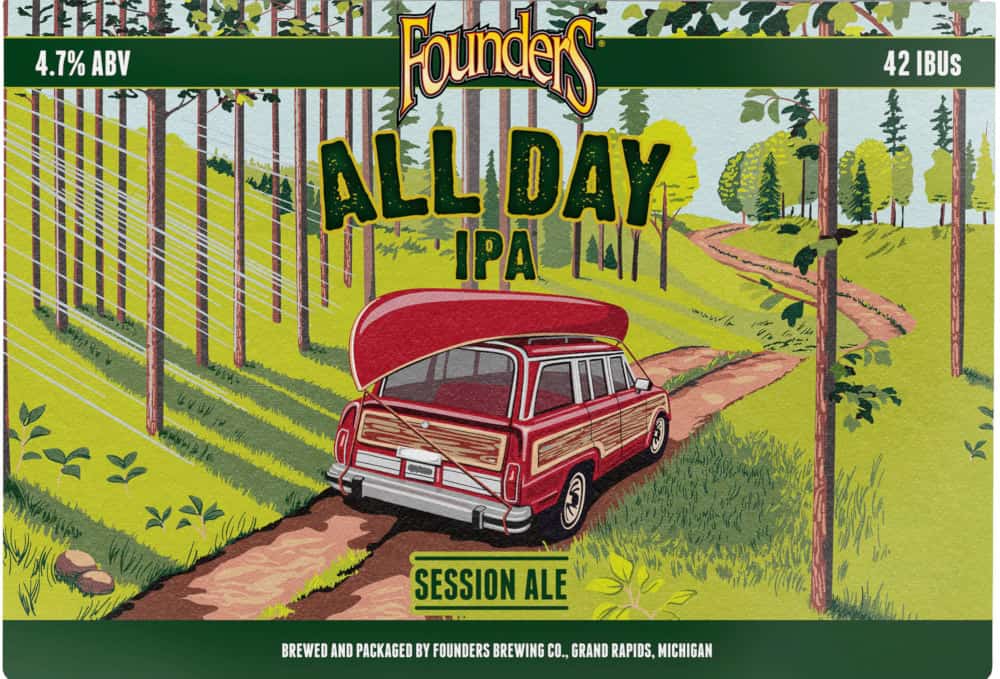Universo IPA: la mappa degli stili della costellazione luppolata
Si fa presto a dire IPA. E invece, dietro a quell’acronimo di tre parole si apre una voragine di significati, diversi tra loro per sfumature spesso tanto sottili quanto rilevanti. In primo luogo, a monte c’è la distinzione tra l’archetipo britannico (oggi designato come English IPA) e la sua versione statunitense (American IPA o, meno frequentemente AIPA).
Una distinzione sulla quale non è mai eccessivo insistere, data la misura con cui la secondogenita (quella a stelle e strisce) ha eclissato, nel gradimento e nella percezione generale, la figura della capostipite, tanto che, nell’immaginario della stragrande maggioranza dei consumatori la IPA viene considerata una tipologia made in USA. Ecco, oltre a questo, c’è poi l’affollata progenie alla quale la stessa American Ipa ha dato luogo nel tempo, attraverso una molteplicità di declinazioni, modellate inserendo, sostituendo, incrementando o diminuendo uno o più ingredienti rispetto alla ricetta originaria. In questo approfondimento abbiamo voluto proporre un riepilogo ordinato di quella che è la discendenza delle IPA di stampo americano.
AMERICAN IPA
Senza tornare a parlare della genesi e delle caratteristiche della IPA primigenia, quella venuta alla luce in Inghilterra, andiamo dritti al punto di divergenza: la comparsa di un’interpretazione di IPA caratterizzata dalle connotazioni organolettiche tipiche dei luppoli USA. Sembrerà paradossale, ma il titolo di matriarca della tipologia spetta a un’etichetta che in realtà AIPA non si è mai chiamata né lo ha mai voluto: la Liberty Ale della Anchor (San Francisco), che viene lanciata nel 1975 come etichetta celebrativa. La ricetta – primo tratto inedito – prevede l’uso massiccio di Cascade, pioniere e portabandiera dei luppoli a stelle e strisce (47 le IBU: mostruose al tempo), gettato in dry hopping (secondo primato), e senza alcun apporto di altre varietà ovvero in formula monovarietale (terzo primato).
Il punto è che, sebbene allora l’intenzione non sia quella di dar vita a un genere nuovo, è di fatto quello che succederà, a fronte di una distanza genetica già in quel primo vagito troppo marcata rispetto al modello originario, e per giunta destinata ad allargarsi: attraverso l’aumento ulteriore delle gettate di “odorosi coni”, sia in early- sia late- sia in dry-hopping; attraverso la messa in commercio, da parte dei laboratori agronomici d’oltreoceano, di cultivar sempre più numerose e assortite nelle qualità organolettiche; attraverso la sperimentazione di diverse tecniche di esecuzione della stessa luppolatura. Processi destinati a plasmare un profilo sensoriale secondo standard che, oggi, possiamo riassumere come segue.
Il colore varia dal dorato carico all’ambrato anche intenso; mentre l’aspetto, un tempo sottilmente velato e poi via via più limpido, attualmente varia in funzione dei sottostili in cui si articola la AIPA; la schiuma è di norma abbondante e durevole. L’aroma prevede, sì, la presenza di una base maltata (specie nelle versioni più scure, con toni di cereale, panificato, un pizzico di tostato), ma assegna senza ombra di dubbio la supremazia alle vigorose impronte del luppolo: frutta esotica, agrumi, resine, temi balsamici. Il gusto è specularmente orientato all’amaricante, con valori in Ibu da 40 a 70 e con componenti morbide in funzione gregarie di bilanciamento, tra esse un contenuto alcolico che, di solito, varia tra i 5,5 e i 7 gradi.
WEST COAST IPA / EAST COAST IPA
Come nella parabola di quasi tutte le egemonie anche le American IPA hanno conosciuto la loro lacerazione interna. Occhio però, qui non si parla di estensioni del genere di riferimento (Black, White, Double, Session), ma piuttosto di una separazione intervenuta a dividere in due campi un territorio produttivo e sensoriale inizialmente occupato in modo omogeneo e unitario dalla definizione, appunto, di AIPA.
Succede infatti che all’inizio del nuovo millennio inizia a delinearsi una via via più netta difformità di visione tra gli interpreti localizzati lungo la costa occidentale (Stati di California, Oregon, Washington) e quelli della costa orientale: una divergenza che finisce per tradursi in due diverse filosofie e, in conclusione, in due distinti sottostili. Da un lato le West Coast IPA, contrassegnate da colori brillanti e aspetto tendenzialmente limpido, privo di opacità sensibili; da profumi in prevalenza agrumati, floreali, erbacei e resinosi; da una corporeità affilata e da un finale perentorio nel taglio amaricante. Dalla parte opposta le East Coast IPA, caratterizzate invece da un bilanciamento olfattivo tendente a sottolineare l’agrumato, nonché incline a concedere maggior spazio alle basi maltate e a un’impalcatura palatale essa stessa più morbidamente maltata e a un iter gustativo chiuso da un taglio bitter meno veemente.
NEW ENGLAND IPA o NEIPA
Sul versante Est l’evoluzione delle Ipa non si fermò. Nell’area del Nordest, e, in modo ancora più specifico, del New England (New Hampshire, Maine, Vermont), cominciarono ad affacciarsi birre divenute famose poi con l’etichetta di New England IPA o NEIPA. La propensione per luppoli concentrati non solo sugli agrumi, ma anche e soprattutto sul tropicale; l’utilizzo di lieviti tali da produrre una bassa flocculazione e a generare non solo esterificazioni, ma anche anche quote di glicerina; una composizione della miscela secca orientata all’utilizzo di ingredienti quali cereali proteici (segale, frumento, avena) e talora, di lattosio o pectina della frutta, contribuirono alla nascita di un nuovo modello destinato a dettare legge.
Con il termine New England IPA si cominciò ad identificare non soltanto una birra opalescente, ma una luppolatura in aroma esplosiva e propendente in primis alla frutta esotica, un arco olfattivo comprendente anche esterificazioni fermentative, un amaro contenuto, un’attenuazione non accentuata e un corpo rotondo, grazie anche a fattori che possono includere l’impiego di quei lieviti inclini a generare glicerina nel proprio metabolismo. Focalizzando questo punto di divergenza, gli esordi delle NEIPA possono esser fatti risalire al debutto, sul mercato, della Heady Topper targata The Alchemist (a Stowe, nel Vermont): brassata dal 2003, all’inizio resta un prodotto marginale, soprattutto perché somministrata soltanto in spillatura, al bancone della tap-room; poi, nel 2011, il passaggio al confezionamento in lattina, grazie al quale la birra può veleggiare verso tutti i quattro punti cardinali, facendosi conoscere, apprezzare e, incredibile, infrangendo l’assioma della limpidezza. È quella l’aurora, come i fatti successivi avrebbero sancito, di una nuova era brassicola.
JUICY IPA / FRUIT IPA / MILKSHAKE IPA
È evidente come la parte iniziale del cammino compiuto da quelle che oggi si percepiscono come Juicy IPA coincide con la strada percorsa, nella propria fase di lancio, dalle stesse, appena trattate, NEIPA. Eppure, nel sentire comune, si arriva a un punto cruciale, in corrispondenza del quale i due percorsi iniziano a distinguersi, se non proprio a separarsi. E così, nel momento in cui scriviamo, ci sentiamo di testimoniare come una designazione quale Juicy IPA si applica a prodotti effettivamente torbidi o comunque molto velati, per effetto di quelle opzioni procedurali alle quali si affida l’effetto “haziness”: colloidi di cereali non maltati; breve o nullo protein rest; rinuncia a significative manovre di chiarifica e scelta di lieviti a bassa flocculazione tali da non dar tempo agli elementi opacizzanti del luppoli di aderire alle proprie cellule precipitando con esse.
E non è finita, perché potrebbe non essere superfluo distinguere mediante una locuzione ad hoc, magari quella di Fruit Ipa, se l’effetto opalescenza derivi appunto dall’aggiunta di fibre di frutta in polpa; consegnando invece la categorizzazione di Milkshake Ipa alle ricette nelle quali si faccia uso anche di lattosio. Due etichette di riferimento di quest’ultima sotto-tipologia: la Smoothie IPA, varata nel 2014 dalla beer-firm svedese Omnipollo, e la Milkshake IPA, firmata nel 2015 dagli americani di Tired Hands (Ardmore, Pennsylvania), peraltro in collaborazione con Omnipollo stessa. Sfogliando tra gli annali si constata però come già nel 2008 il marchio Three Floyds (Munster, Indiana) faccia uscire la sua Apocalypse Cow, Double IPA corazzata da 9.5 gradi alcolici all’esordio (poi saliti a 11) e da ben 100 IBU, brassata, inusualmente per le abitudini di allora, con aggiunta di lattosio.
DOUBLE IPA
Contrassegnate nella loro parabola esistenziale, da una sorta di “corsa al riarmo” nell’utilizzo del luppolo, le American IPA hanno imboccato la strada dell’incremento esponenziale delle proprie muscolature anche in riferimento al valore alcolico. Tanto da generare, al culmine di tale processo, una tipologia a sé stante, battezzata come Imperial IPA o Double IPA. Il “padre” della tipologia è Vinnie Cilurzo, attuale comproprietario del marchio californiano Russian River (a Santa Rosa), ma inizialmente “semplice” brewmaster; e, prima ancora, negli anni Novanta del Novecento, titolare dello stesso ruolo alla Blind Pig Brewery di Temecula (sempre California).
È qui che, nel 1994, in occasione del primo compleanno dell’attività, viene servita la Inaugural Ale: un’American IPA brassata con una valanga di luppolo, sia in amaro (le fonti parlano di 100 o 92 Ibu, da gettate di Chinook) sia in aroma (Chinook e Centennial); e con un’alcolicità tra il 6,5 e il 7%. Sul fondamento di questa esperienza Cilurzo, passato sotto le insegne della Russian River, firmerà due ricette ben note come quelle della Blind Pig Ipa (6 gradi e 75 IBU, da Cascade e Columbus) e della Pliny the Elder (qui i gradi sono 8), che, per un vasto immaginario collettivo, corrispondente alla Double IPA di riferimento.
Ma qual è di queste maggiorate, la fisionomia in termini organolettici? Il colore spazia tra il limite inferiore del dorato a quello superiore del ramato; la grana ottica si muove di norma attorno a standard di pulizia da propriamente limpidi a leggermente velati; la schiuma forma una testa moderatamente ampia. L’aroma fa apprezzare interessanti base maltate, inclini a esprimersi nelle fattispecie delle frolla, del biscotto e del caramello; ma pone senza equivoci in primo piano gli apporti del luppolo, con ventilazioni di stampo agrumato, fruttato-esotico e resinoso-balsamico. Le stesse che troviamo al sorseggio nel definire una condotta morbida e bilanciata in valori di alta intensità sensoriale: i gradi alcolici oscillano più o meno tra 7,5 e 10; mentre il tenore amaricante corre sul binario di un ammontare di IBU compreso tra le 60 e le 120 unità, sfogando le proprie veemenze in una chiusura di bocca che, comunque, mei dovrebbe risultare arrogante.
BLACK IPA
Sono le American IPA costruite su basi che, visivamente, richiamano le sembianze di una Porter o di una Stout, meglio ancora di una Schwarzbier per via di certe rotondità tipiche delle scure tedesche di ascendenza turingese. L’antesignana delle Black IPA sembrerebbe essere quella lanciata, già nel 1994, col nome di Blackwatch, dal Vermont Pub & Brewery, a Burlington, grazie a un’intuizione del suo fondatore, Greg Noonan. Prima di parlare del suo identikit organolettico odierno, merita riportare qualche doveroso cenno sul processo di canonizzazione della tipologia che, entrata in scena con un significativo numero di esempi nella seconda metà del primo decennio del Duemila, è stata adottata formalmente nel 2010 dalle Style Guidelines della BA (Brewers Association) e poi, nel 2014, da quelle del BJCP (Beer Judge Certification Program).
Si tratta di una dicitura attorno alla cui formulazione si è discusso parecchio fin dal nome stesso, Black India Pale Ale, che rivela una contraddizione evidente (una birra o è Black o è Pale); e che alla fine è stata accolta dopo un lungo ballottaggio con diverse locuzioni alternative e concorrenti, da Cascadian Dark ad American Black, passando per India Black Ale. Per quanto riguarda il profilo sensoriale dello stile il colore oscilla tra le tonalità del bruno intenso a quelle del mogano; la trama visiva è spesso impenetrabile e nei casi di maggiore pulizia l’aspetto può essere più o meno velato; la schiuma (consistente) riporta tinteggiature in scala (ocra, beige, avorio) con la massa liquida. L’aroma e il gusto spiccano per la vivace luppolatura (nella quale si evidenziano i temi degli agrumi e delle resine), alla quale si affianca una lieve inclinazione tostato-torrefatta. La condotta palatale è, nelle migliori edizioni, morbida, grazie all’incidenza di componenti morbide (tra cui una percentuale alcolica statisticamente attestata tra i 5,5 e i 9 gradi), la cui spinta compensa quella di una parabola amaricante dalla chiusura vigorosa (le IBU vanno da 50 a 90) ma non ruvida, anzi levigata.
BELGIAN IPA
Comparse attorno alla metà del primo decennio di questo secolo, sotto il profilo progettuale costituiscono evidentemente un crossover tra due classi di ingredienti, ciascuna apportatrice di uno specifico Dna. Da un lato i lieviti (strenui esterificatori) tipici del repertorio riconducibile alle terre tra Fiandre e Vallonia. Dall’altro i luppoli, in particolare quelli provenienti dai filari svettanti sui campi degli Stati Uniti. Il primato cronologico del debutto ufficiale va probabilmente riconosciuto alla Urthel Hop-it della Brouwerij De Leyerth (Ruiselede, Fiandre Occidentali) nata nel 2005; a ruota, nel 2006, seguita dalle connazionali De Ranke XX Bitter e Chouffe Houblon. Mentre il primo esempio commerciale americano va rintracciato nella Cali-Belgique targata Stone (marchio di San Diego), partorita nel 2008. Una parabola evolutiva che negli anni si è orientata alla valorizzazione del genoma “a stelle e strisce”, pur senza mortificare la quota di corredo cromosomico europeo, riconducibile segnatamente ai generi delle Tripel e delle Belgian Golden Strong Ale.
Nell’insieme abbiamo un identikit sensoriale da pesi medio-massimi delle gradazioni alcoliche (il cui registro si muove tra i 6 e i 9 gradi); e da campionesse del binomio “aroma e amaro” (con la lancetta delle IBU a oscillare tra quota 50 e quota 100). Il loro colore arriva fino all’ambrato e può scalare fino al dorato, soprattutto nelle versioni elaborate al di qua dell’oceano: spesso descritte tuttora come Tripel in versione luppolata, e non di rado portate a prediligere coni di varietà continentale. L’aroma amalgama i contributi odorosi e gustativi del luppolo di estrazione nuovomondista e quindi dalle tinte agrumate, esotiche e resinose, con quelli aromatico-fermentativi tipici dei lieviti belgi: frutta matura, fiori, spezie (quali pepe e chiodo di garofano). L’assetto palatale, infine, fa alleare le accennate energie etiliche, con quelle delle robuste basi maltate (caramello, miele, frolla) e con quelle amaricanti dei coni gettati in bollitura, la cui zampata contrassegna la chiusura della bevuta.
SESSION IPA
Quasi inesorabilmente in applicazione di quel principio fisico per cui a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, il “primo vagito” della Imperial IPA mette in moto un meccanismo per cui, qualche anno dopo, lo scacchiere statunitense registra la nascita di quella che potremmo definire come la versione “al negativo” della DIPA stessa: la Session IPA. È infatti il 2010 quando, tra le mura della Founders Brewing Company (nel Michigan), l’attuale birraio capo Jeremy Kosmicki mette a punto la ricetta della All Day IPA: un piccolo ordigno sensoriale contenuto in 4,7 gradi alcolici, che, dopo un oculato collaudo, viene confezionato a partire dal 2012, generando un’onda imitativa impressionante e imponendo la messa in agenda di un genere nuovo. Un genere il cui riconoscimento sostanziale è datato 2015: anno in cui la categoria Session IPA viene inserita sia dalla Brewers Association (BA) nell’elenco delle proprie Styles Guidelines; sia dal Great American Beer Festival tra le proprie classi di concorso.
Si tratta di un perimetro di esecuzione del canovaccio AIPA che definisce un territorio concettuale e sensoriale fortemente apprezzato nella pratica di produzione, somministrazione e consumo, proprio per la capacità di coniugare esplosività luppolate e disinvoltura di fruizione. Un filone a sostegno del quale crescono di anno in anno proseliti e simpatizzanti. Nella denominazione Session IPA, l’apposizione prefissuale indica evidentemente il basso tenore alcolico, oscillante di solito fra il 3 abbondante e il 4,5% (sebbene, formalmente, i testi della BA allarghino le maglie alcoliche fino al 5 gradi). L’abbassamento dell’asticella alcolica non limita le cospicue gettate di luppolo in aroma, anzi, l’idea è proprio quella di offrire una spinta nasale decisamente energica, naturalmente nelle direzioni consuete della frutta esotica, degli agrumi, del resinoso balsamico. Dall’arco olfattivo non sono peraltro pregiudizialmente escluse tematiche maltate: sebbene le versioni in chiaro siano nettamente prevalenti, lo spettro cromatico infatti va dal paglierino all’ambrato intenso, includendo quindi latitudini in corrispondenza delle quali il cereale tende a farsi avvertire. L’orientamento, comunque, è a non calcare la mano con le tostature; e, parallelamente, a smussare la bitterness (benché la BA parli di valori in IBU fra 30 e 55), evitando così intemperanze e astringenze.
WHITE IPA
Questa tipologia, ufficializzata nell’ambito dell’infornata di canonizzazioni per la quale si è contraddistinta la revisione 2015 delle Linee Guida Bjcp, presenta natali alquanto recenti, e che, al netto di una fase di gestazione maturata anche negli anni precedenti, rivela una storia il cui inizio formale si fa risalire allo scorcio finale del 2010. È allora che la collaborazione tra due birrifici esponenti di altrettante ben diverse filosofie produttive come la “westcoaster” Deschutes Brewery di Bend (Oregon) e la Boulevard Brewing Company di Kansas City (Missouri), da vita alla Conflux 2.
Di fatto un archetipo a immagine del quale si sviluppa un filone che, da allora, contempla la possibilità di utilizzare orzo e frumento, luppoli e spezie (queste comunque non prescritte come essenziali), lieviti neutri (di matrice statunitense) e altri più propensi a esterificare (ceppi selezionati da Witbier) secondo i canoni vigenti tra i ceppi di Fiandra e Vallonia. Pur tra alti e bassi, il genere conoscerà, negli anni, un certo riscontro, e oggi lo stile trova una definizione nel cui recinto statistico di riferimento si ammettono interpretazioni mediamente collocate tra le 40 e le 70 Ibu (da cui deriva un amaricante ben netto); con uno spazio di manovra, sulla scala alcolica, che va dal 5.5 al 7%. Ne deriva un colore dorato dal pallido al pieno, con trama velata; un corredo odoroso che unisce frutta e spezie fermentative (banana, albicocca, pepe, chiodo di garofano) a trame luppolate (agrumi, floreale) e all’eventuale ulteriore apporto speziato da aggiunte dirette; un assetto gustativo dal fondo panificato, con una lieve acidulità rinfrescante e una chiusura bitter, di bella pulizia.
SOUR IPA
Stiamo parlando di birre provviste di una luppolatura in aroma da AIPA e di un impianto gustativo-palatale ricalcante invece quelli di un genere acido come Brett Beer, Gose, Berliner Weisse. Un prodotto, quello delle Sour Ipa, entrato piuttosto rapidamente nel novero degli usi e costumi quotidianamente praticati da produttori e consumatori, che ha visto la sua entrata in scena a partire dal 2012 per poi affermarsi nel triennio successivo.
Dalle settimane di transizione tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, si comincia a parlare, in termini di classificazione, da un lato di Brett Ipa (con inoculo controllato cioè di lieviti selvatici a fini non necessariamente legati all’affossamento del pH); e dall’altro di Tart Ipa, nel loro caso, sì, intenzionalmente caratterizzate da un’esplicita curvatura gustolfattiva di tipo acre. Concentrandoci su queste ultime, il primo marchio a muoversi consapevolmente in tale direzione (fin dal principio orientata dall’impiego di lattobacilli secondo la tecnica del kettle-souring) sembra essere, in base alle fonti, quello, danese all’anagrafe ma cosmopolita per vocazione, di Evil Twin, con la Sour Bikini, uscita nel 2012 come Sour Pale Ale, con una titolazione alcolica pari al 3% in volume.
PACIFIC IPA
Una menzione altrettanto necessaria, in quanto la definizione risulta regolarmente (se non proprio diffusamente) utilizzata, spetta alle Pacific IPA. Ovvero a quelle versioni della India Pale Ale che, declinate secondo le direzioni proprie di luppoli nuovomondisti, si avvalgono, però, di varietà aromatiche non (o non primariamente) statunitensi, bensì in toto o principalmente appartenenti al paniere del quadrante geografico che corrisponde, appunto, al Sud-Ovest dell’Oceano Pacifico. Varietà quali le australiane Summer, Stella, Galaxy e Vic Secret; le neozelandesi Nelson Sauvin, Motueka, Pacifica e Wai-Iti; o la giapponese Sorachi Ace.
RYE IPA
Una variante delle AIPA che si afferma a partire dai primi anni dopo il Duemila e che si caratterizzata dall’impiego di segale (presente in forma maltata fino al 20% dell’impasto) è quella delle Rye IPA. Tendenti a esprimere valori amaricanti significativi (Ibu da 50 a 75) e provviste di contenuti alcolici oscillanti (in linea di massima, dal 5.5 all’8%), le Rye IPA presentano colori ambrati di tonalità più o meno rosseggiante, dovuta all’impiego del cereale distintivo; di cui ammettono (a livello palatale-gustativo) la tipica nota tostata e lievemente piccante, nonché talvolta di delicata tannicità. Mentre l’aroma – normalmente bassa l’esterificazione da lieviti (inglesi o americani – si avvale principalmente degli apporti del luppolo.
TRIPLE IPA
Al boom vissuto in questi ultimi anni dalle NEIPA è legata la messa in moto di un meccanismo volto alla scoperta o alla riscoperta di territori stilistici vecchi e nuovi territori. Uno di questi è quello delle Triple IPA, locuzione tale da far pensare, già d’istinto, a qualcosa che vada oltre le Double IPA, specie in termini di gradi alcolici, dai dieci a salire. Si tratta in effetti di prodotti ottenuti applicando una regola piuttosto semplice: esasperare una ricetta, se non limitarsi strettamente a raddoppiare la quantità degli ingredienti.
L’aumento esponenziale delle quantità di cereale in miscela si trasferisce al corpo della birra rendendolo massiccio, poderoso, imponente, capace di reggere persino un buon invecchiamento; e il luppolo fa, sì, la propria parte, ma come contraltare. L’effetto finale non è tanto dissimile da quello di un American Barley Wine, meno complesso: ingresso dolce dalla robusta impronta maltata, lunga uscita amara e secca, il tutto pervaso da un tenore alcolico di una certa importanza.
EXTRA BRUT IPA
Si tratta di una declinazione della India Pale Ale su cui l’interesse di produttori e osservatori si è accentrato con una certa insistenza nella prima metà del 2018, per poi perdere buona parte di quella spinta iniziale, particolarmente vigorosa: una sottotipologia battezzata come Extra Brut IPA. Chiamata anche Hop Champagne, si muove in plateale controtendenza rispetto alle NEIPA: evidenziando nello specifico requisiti di alta carbonazione, corporatura leggera e finale molto secco. L’idea consiste nel ricorrere all’aggiunta di enzimi che contribuiscono a rendere totalmente fermentabili gli zuccheri complessi presenti nel mosto, così da raggiungere un’asciuttezza estrema e un aumento della gradazione alcolica.