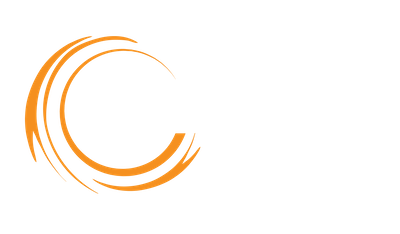Strong o light beer? Come cambia il grado alcolico della birra nella storia
Quando si tengono lezioni di degustazione di livello base o, semplicemente, si chiacchiera della nostra bevanda preferita con neofiti o non addetti ai lavori, accade sovente di affrontare il tema delle significative differenze di gradazione alcolica sussistenti tra le grandi nazioni di tradizione birraria in tema di “bevuta media”: uno dei più facili paragoni in proposito riguarda la contrapposizione tra i due estremi rappresentati da una parte dal Regno Unito o dal Nord Europa, ove una birra con 6% di alcol in volume è etichettata come strong ale o starköl, e dall’altra dal Belgio, in cui una cervogia con il medesimo tenore alcolico può essere facilmente la referenza più leggera presenta nel menù. Quasi sempre, in queste occasioni informali, le ragioni di tale conflitto vengono sommariamente e inesattamente fatte risalire a una presunta diversa attitudine innata presente nelle popolazioni, come se esistesse una sorta di inclinazione etilica funzionale all’etnia: si tratta di una spiegazione per certi versi “romantica” e che sicuramente soddisfa l’istinto alla semplificazione che costantemente accompagna l’agire e il sapere umani ma che rimane assai lontana dal vero.

La gradazione alcolica delle birre prevalentemente presenti sul mercato in una certa nazione e in un dato momento storico è infatti legata a ben più concreti e prosaici fattori legati alle legislazioni vigenti, ai costi delle materie prime, alla tassazione e, non meno importante, alla reputazione sociale che le bevande spiritose e il loro consumo assumono in quelle determinate circostanze.
La maggiore solidità di questo genere di argomenti emerge del resto in modo lampante quando si pensa alla situazione dei paesi scandinavi, ove la capillare diffusione di birre quotidiane a bassissimo tenore etilico o addirittura analcoliche trae le sue origini da legislazioni estremamente restrittive sul consumo di alcol, che si estrinsecano in un’elevata e graduata età d’accesso alle diverse bevande alcoliche, accompagnata da un severo controllo statale e una forte pressione fiscale sulla vendita, che comporta prezzi elevati e necessità di esibire un documento d’identità per l’acquisto.
Allo stesso modo, se riflettiamo sull’attuale crescente trend delle birre analcoliche, che da anni rappresentano il 10% del mercato in Paesi non certo astemi come Austria e Germania, e ora stanno sempre più attirando l’interesse anche dei microbirrifici italiani, possiamo reperire eterogenee ma correlate cause concomitanti quali:
– norme più restrittive e sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza. In Italia tale fattore è inoltre reso ancora più impattante dall’amara constatazione che, a fronte di un apparato sanzionatorio sempre più draconiano, non vi sia un contemporaneo investimento nell’incremento del trasporto pubblico nelle ore serali e nemmeno, misura che sarebbe assai meno gravosa per i conti pubblici, una liberalizzazione delle licenze dei taxi e delle piattaforme come Uber. Le narrazioni giornalistiche hanno inoltre portato un notevole incremento dello stigma sociale sulla guida in stato di ebbrezza rispetto a quanto accadesse due o tre decenni fa.
– maggiore attenzione da parte di una vasta fascia della popolazioni ad aspetti salutistici e dietetici, non di rado legato a pratiche sportive e di fitness, che portano a diminuire il consumo complessivo di alcol sia focalizzandosi su prodotti di maggiore qualità che prediligendo bevande a basso tenore alcolico.
– minore interesse da parte della parte più giovane della popolazione maggiorenne: gli zoomers o generazione Z paiono infatti subire molto meno l’attrazione fatale dell’alcol rispetto a millennials, generazione X e boomers.

Se volgiamo gli occhi al passato, la prima, macroscopica considerazione è che il consumo di bevande alcoliche “quotidiane” è costantemente calato a partire dalla fine del XIX secolo a causa delle diverse esigenze nutrizionali e sociali sopravvenute nei paesi industrializzati: se nei secoli precedenti per la gran parte della popolazione che svolgeva lavori prevalentemente fisici nei campi o nelle fabbriche la birra e, nei paesi mediterranei, il vino, fungevano da integratori calorici che andavano a rinforzare un’alimentazione spesso frugale e poco varia, il passaggio della gran parte della forza di lavoro in attività più sedentarie congiuntamente alla crescita e diffusione di numerose alternative alla taverna per l’impiego del tempo libero, ha portato a una massiccia diminuzione del consumo pro capite e, si dice spesso, a una richiesta di bevande più leggere e meno inebrianti.
Per quanto riguarda il tenore alcolico delle birre quotidiane, dobbiamo inoltre pensare che fino alla fine del Settecento si brassava essenzialmente con la tecnica del party gyle e quindi sul mercato erano reperibili sia le più pregiate e costose birre ottenute dal primo mosto, con una gradazione alcolica generalmente superiore a ciò che siamo abituati ordinariamente a bere oggi, che quelle più economiche (e per questo più diffuse) derivate dal secondo e terzo risciacquo delle trebbie, le quali al contrario erano etilicamente assai più leggere rispetto alle più comuni consumazioni odierne. Un altro fattore che spesso si sottovaluta e su cui poco oltre si tornerà con alcuni dati numerici è l’attenuazione, che in passato era molto più ridotta: in altre parole, a parità di gravità iniziale, si bevevano birre con meno alcol svolto e un residuo zuccherino decisamente più elevato rispetto ad oggi, fattore del resto coerente con la valenza alimentare della nostra bevanda preferita. Date queste premesse, è già capitato in passato di assistere a mutamenti al ribasso, o, all’opposto, al rialzo della gradazione alcolica delle bevuta quotidiana: la storia della birra è piena di corsi e ricorsi in questo senso.
Inghilterra
Il grande lavoro storico di Martyn Cornell ci ha dato, ad esempio, un quadro molto dettagliato di come la politica interna ed estera e le connesse manovre fiscali abbiano influito pesantemente sulla gradazione delle pinte bevute dai britannici nei pub nel corso dei secoli. Lo storico di Norwich ci rivela infatti che nel 1880, quando il Gladstone Licensing Act eliminò la tassazione sul malto d’orzo per introdurne una sulla birra finita, la densità media del mosto a partire da cui calcolare i vari scalini fiscali, sia in alto che in basso, era stata determinata in 1057 O.G, una gravità decisamente più elevata di quella delle Ordinary e delle Best Bitter di oggi. Gladstone, con la sua norma, non favorì inoltre la qualità del prodotto, perché il suggerimento implicito contenuto nella riforma era che i birrai potevano diminuire la presenza del più costoso malto d’orzo a favore di fermentescibili più economici come riso e granturco. Il nuovo regime fiscale favorì infatti i grandi produttori che avevano adottato una logica industriale penalizzando i piccoli birrifici locali: proprio per evitare un eccessivo svantaggio competitivo alle birrerie di dimensioni minori, nel 1889 la densità media venne rivista al ribasso e assestata a 1055 OG.
Fu questo solo il primo di una lunga serie di salti verso il basso della gradazione delle pinte inglesi che si succederanno nei primi decenni del Novecento a causa sia delle guerre, con i connessi incrementi della pressione fiscale e restrizione della disponibilità di cereali al fine di evitare carenze alimentari, che della crescente influenza dei movimenti per la temperanza che trovavano una forte sponda politica nel partito liberale di David Lloyd George (mentre la lobby dei birrai appoggiava esplicitamente il partito conservatore). Una prima stangata fiscale fu l’aumento del 24% della tassa sulla produzione di birra nel 1900 per finanziare la guerra anglo-boera, imposta che non venne però rimossa al termine del conflitto (ricorda qualcosa a noi italiani?) mentre, per strizzare l’occhio a chi chiedeva che le bevande fossero meno alcoliche e più giovevoli alla salute, nel 1910 la birreria Mackeson di Hythe, nel Kent, lanciò sul mercato una birra scura con solo il 3% di alcol in volume e aggiunta di lattosio infermentescibile, ovvero la prima Milk Stout.
Fu però con la Prima Guerra Mondiale che il mutamento divenne drastico: la carenza di materie prime portò il governo a determinare nel 1915 una riduzione del 15% della produzione nazionale di birra rispetto all’anno precedente. Il taglio era calcolato basandosi su un OG media di 1055, era poi discrezione dei birrifici scegliere se produrre meno birra con la stessa densità o più birra leggera: la seconda opzione fu ovviamente la più gettonata e nel 1917 si arrivò addirittura a tagliare la produzione del 70% rispetto al biennio precedente. La poca birra che circolava era quindi oltremodo “light” tanto che un musicista di nome Ernie Mayne compose una canzone satirica dedicata alla Government Ale o Lloyd George Beer. Il leader liberale, nel frattempo divenuto primo ministro, non mancava di esortare i cittadini all’astinenza alcolica sostenendo come l’inclinazione dei britannici al bicchiere fosse un nemico ancora più tenace della Triplice Alleanza. Se nel secolo precedente la birra era lodata come bevanda temperante rispetto al gin, ora era proprio il nettare di malto ad essere il bersaglio della propaganda governativa, con il supporto dei movimenti per la temperanza.

Nel 1918, ultimo anno di sforzo bellico, arrivò un ulteriore giro di vite con l’imposizione ai birrifici di non superare un OG di 1030 su almeno il 50% della propria produzione: solo per l’Irlanda, all’epoca ancora sotto il controllo britannico, il limite era spostato a 1045 OG, sia perché i grandi produttori come Guinness non avrebbero potuto realizzare una Stout dignitosa con un OG inferiore, sia per non fornire agli irlandesi ulteriori motivi di malcontento. Il risultato permanente della Grande Guerra, ci ricorda sempre Cornell, fu quello di decurtare di almeno il 25% il tenore alcolico di tutte le tipologie birrarie allora esistenti: le Porter passarono da una media di 1055 OG del periodo prebellico a 1036 OG, le IPA da 1065 a 1048 e le Mild da 1048 a 1032. Il rimbalzo incrementale dopo la fine del conflitto fu infatti minimo: nel 1919 la densità media di riferimento per i computi fiscali fu riportata a 1044 OG in Inghilterra e a 1051 OG in Irlanda, ove la Guinness Extra Stout, che era passata dai 1074 OG del 1914 ai 1048 del 1918, tornò solo a 1054 OG in epoca post bellica.
La Seconda Guerra Mondiale portò ad ancora più gravi carenze di materie prime, tanto che negli anni più bui del conflitto si arrivarono ad usare anche fiocchi di patate oltreché di mais e di avena come materiale fermentescibile, ma, al contrario di Lloyd George, il governo del conservatore Winston Churchill, la cui inclinazione alcolica era ben nota, non invitò mai i cittadini alla temperanza o all’astinenza, ritenendo la birra e i pub un fattore cruciale per la tenuta del fronte interno. Il rapporto qualità/prezzo di ciò che i consumatori bevevano, comunque, subì un brusco peggioramento: a fronte di un incremento di circa il 60% del costo di una pinta di Mild, all’epoca la bevuta quotidiana della classe lavoratrice, la gravità originaria media delle birre in commercio scese dai 1040 OG del 1939 ai 1034 OG del 1942, a cui si aggiunse nel 1941 un taglio del 20% delle quantità di luppolo utilizzabile, e nel 1943 una suddivisione del Paese in zone dove i produttori erano obbligati a commerciare le loro birre. Nel mentre le tipologie più forti e costose come le Burton Ale sparirono completamente dal mercato. La fine del conflitto lasciò in eredità un taglio definitivo del 10% del tenore alcolico rispetto agli anni antecedenti al 1939, che andava sommato al 25% perso durante la Prima Guerra Mondiale Uno dei principali effetti fu la scomparsa di fatto delle IPA, che si resero sempre più indistinguibili dalle Pale Ale o Bitter. Se prima del 1914 le IPA avevano infatti un OG media di 1070, negli anni Trenta la Ind Coope di Burton on Trent brassava una IPA la cui OG, pari a 1041, era inferiore a quella della loro Best Bitter (1046). Allo stesso modo la birreria Benskin’s di Watford negli anni Cinquanta aveva in catalogo una IPA da 1041 OG mentre la loro Pale Ale titolava 1037 OG. Non è un caso che un libro edito nel 1948 dal titolo The Brewer’s Art pubblicato da Whitbread sostenesse come il termine India Pale Ale fosse “ormai praticamente obsoleto”.
Le IPA scomparse dalla madrepatria divennero però il simbolo della rivoluzione craft statunitense che, dal 1976, ha riportato nei frigoriferi degli americani birre importanti sia per impatto gustativo che per tenore alcolico dopo decenni di monopolio delle light lager. Anche in questo caso la politica ebbe per due volte un ruolo decisivo. Il quindicennio del proibizionismo, con il dominio dei soft drink e delle near beer, bevande analcoliche a base di malto, aveva infatti impostato il palato di una generazione su un gusto prevalentemente piatto e dolce, senza ovviamente la pungenza dell’alcol, creando un mercato ideale per le mass market lager, mentre, all’opposto, la legalizzazione dell’homebrewing da parte del presidente Jimmy Carter permise la nascita e la formazione sul campo dei primi microproduttori con le loro birre ben più robuste.
Germania
Spostandoci in Germania è interessante osservare alcuni dati che il manuale del Wahl & Henius Insititute of Fermentology riporta a proposito delle Broyhan, per secoli una popolare tipologia di birra ad alta fermentazione con frumento, leggera e acidula, tipica della zona di Hannover e delle regioni settentrionali poi estinta nel corso del Novecento. Citate nel testo scientifico troviamo infatti: una Breyhan (sic!) brassata ad Halberstadt nel 1850 con un O.G di 1034,7 e una F.G di 1012, un grado alcolico di 2,84% vol. e un pH di 3,32, decisamente basso e in linea con quello delle Berliner Weisse e delle Gueuze dei giorni nostri una Einfacher (letteralmente “semplice”), Broyhan di Hannover del 1884 con 1031,4 di O.G e 1022,5 di F.G, un grado alcolico di 1,03% vol. e un pH di 3,78, in linea con quello attuale di un Lambic piatto una Doppelter Broyhan, specialità citata anche in altre fonti come tipica dei mesi freddi, sempre brassata nel 1884 ad Hannover con O.G di 1053,4 e F.G 1043, un grado alcolico di 1,20% vol. e un pH di 3,99, vicino ai limiti più bassi di quelli delle attuali ale britanniche (4-4,20) e delle Hefeweizen bavaresi (4,10–4,40). Gli eloquenti numeri ci rivelano anche che l’aggettivo Doppel non si riferiva in questo caso al tenore alcolico ma al residuo zuccherino, che era peraltro, sia nella “semplice” che nella “doppia”, spaventosamente elevato rispetto alle birre attuali, e che ci fa intuire quanto sia cambiato il concetto quotidiano della bevanda in direzione di un’attenuazione sempre maggiore come poc’anzi si ricordava.

In un testo del 1907 significativamente intitolato La produzione delle birre ad alta fermentazione nella teoria e nella pratica, firmato da un mastro birraio di nome Grenell, troviamo notizie circa la Hamburger Bier che viene definita “con una O.G tra i 7 e gli 11° Balling, ovvero con un grado alcolico tra i 2,5% e i 3,5% vol., scura, dolce e tipica delle città portuali del nord della Germania”. Dati molto sorprendenti per chi, masticando di storia della birra, ricordi come nei secoli precedenti le Hamburger Bier, chiamate anche Hamburger Weisse, fossero descritte come birre chiare, con malto di frumento e dalla gradazione alcolica piuttosto forte.
Altre fonti confermano inoltre che tra gli ultimi decenni del XIX secolo e il periodo della Grande Guerra in tutta la Germania ma specialmente a settentrione si fossero diffuse birre scure e molto povere d’alcol. Nel tomo scientifico “Le birre ad alta fermentazione e la loro produzione”, opera del 1938 del dottor Franz Schönfeld, si legge come dal 1900 in poi, apparve una nuova tipologia birraria: la Malzbier o Karamellbier, solitamente prodotta con aggiunta di zuccheri e pastorizzata, che diede un forte impulso alla produzione di birre ad alta fermentazione. L’autore testimonia come esistessero produttori appositamente votati a questa tipologia, evidentemente dal basso prezzo e destinata al consumo quotidiano per vaste fasce della popolazione, ma come tali birre venissero anche prodotte da birrifici tradizionali a partire dal secondo risciacquo delle trebbie; non di rado erano inoltre addizionate di zucchero o dolcificanti quali ulteriori materiali fermentescibili e non è difficile dedurre che la sopravvenuta carenza di materie prime negli anni della Prima Guerra Mondiale, in cui l’output dei birrifici si ridusse drasticamente e in quelli immediatamente successivi alla sconfitta tedesca nel conflitto, abbia giocato un ruolo chiave nel loro successo nonché nel successivo oblio dopo gli anni Cinquanta. Spesso queste Malzbier venivano fermentate in birrificio per soli uno o due giorni e poi spedite nelle Stube e taverne ove i gestori concludevano la fermentazione secondaria e la maturazione con un’opportuna apertura del fusto, come avviene ordinariamente per le cask ale britanniche e avveniva anche a Lipsia con le Gose, nonché nella tradizione berlinese sia per le Weisse che per le estinte Berliner Braunbier. Anche i clienti finali, ci rivela sempre Schönfeld, potevano acquistarle al litro dai birrifici come Frischesbier (“birra fresca”), usando secchi o recipienti analoghi con l’accortezza di attendere uno o due giorni prima di consumarle: tale costume, secondo l’autore, era però, già nel 1938, in forte declino e a un passo dalla sparizione.
Belgio
Negli stessi anni in cui la Germania, specie a settentrione, e il Regno Unito vedevano calare la gradazione delle loro birre, il Belgio assisteva al contrario ad un deciso innalzamento dei tenori alcolici e alla nascita della sua fama come Paese delle birre forti per antonomasia. Se si consultano fonti antecedenti al Novecento si trovano infatti notizie di tipologie birrarie belghe, oggi per lo più estinte, contraddistinte dal massiccio uso di frumento e cereali alternativi, ma dalla gradazione moderata. La sempre originale terra dei fiamminghi e valloni era infatti l’unica nazione in cui le imposte sulla produzione birraria non si pagavano sulle materie prime o il prodotto finito, ma sulla dimensione del tino di ammostamento.

Questo bizzarro sistema fiscale induceva ovviamente i birrai a sfruttare al massimo l’impianto produttivo stipandolo il più possibile di materiale fermentescibile e producendo una ridotta quantità di birra molto forte e costosa e, tramite ripetuti sciacqui delle trebbie, birre via via sempre più leggere. Il Mars, prodotto oggi estinto, era ricavato in questo modo dal risciacquo delle trebbie del Lambic; mentre se si studia la storia delle Saison si nota come la loro gradazione media prima del Novecento fosse di 2,5-3,5% di alcol in volume salita poi a 4-5,5% nel primo decennio del Novecento, valore comunque inferiore a quello della maggior parte delle Saison odierne. Cosa è accaduto nel frattempo? Ancora una volta ci ha messo lo zampino la politica: nel 1902 cambiò infatti la normativa fiscale andando a tassare, come in altri Paesi, le materie prime per la produzione birraria, e nel 1919, con i birrifici belgi intenti alla ricostruzione dopo che nella Prima Guerra Mondiale gli invasori tedeschi avevano requisito tutte le caldaie in rame, venne promulgata la legge Vandervelde che, impedendo la vendita nei bar del janvier, l’originario gin fiammingo, creò un mercato per birre ad alta gradazione come le Tripel, che videro la luce poco più di un decennio dopo.
Solo il prosieguo della storia ci dirà se l’attuale tendenza all’alleggerimento, o addirittura all’abolizione della componente alcolica nelle birre, sarà una strada senza ritorno o solo un’onda destinata prima o poi a infrangersi.