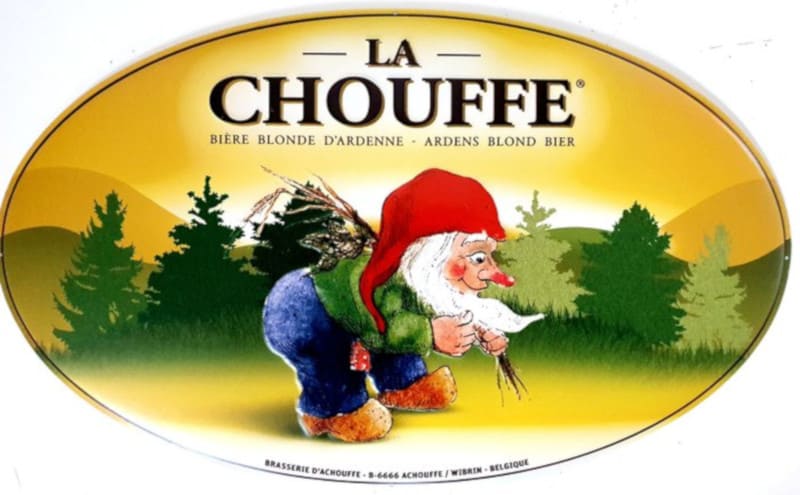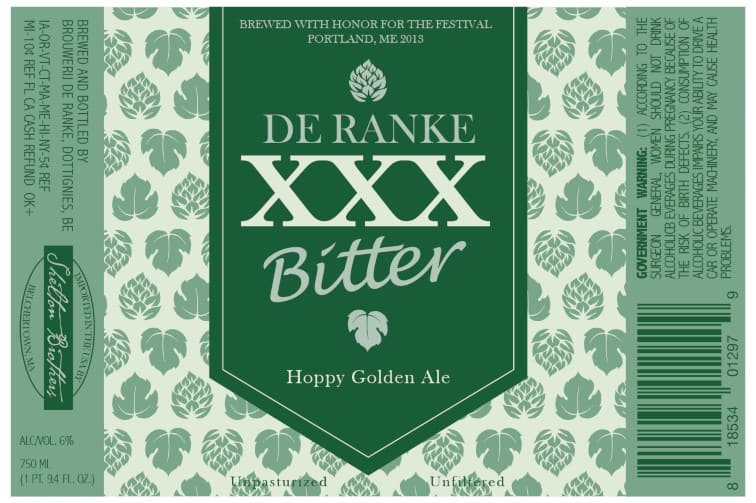Che fine ha fatto il Grande Belgio?
Immaginate un’Italia senza rete Internet e senza microbirrifici artigianali autoctoni: per i più giovani dal punto di vista anagrafico si tratta, appunto, di un esercizio di fantasia, utopico o distopico a seconda dei punti di vista, ma per la platea dei più anziani, quantomeno considerando la vecchiaia della loro passione birraria, è semplicemente il ricordo di un tempo passato e vissuto, che può essere accompagnato da nostalgia o da soddisfazione per averlo lasciato alle spalle.
In questo universo meno vario e complesso, dunque, l’offerta birraria disponibile nel nostro Paese si riduceva a quanto fosse reperibile nei bar e nei pochi pub della propria città, inoltre, situazione che oggi potrebbe sembrare incredibile, per l’appassionato della prima ora non era raro emozionarsi perfino di fronte a uno scaffale di supermercato più fornito rispetto alla media dei concorrenti.
La birra era, per una fetta ben più ampia della popolazione rispetto ad oggi, una lager chiara poco alcolica e vagamente amarognola prodotta da un birrificio industriale italiano oppure importata da Germania, Austria o Nord Europa e l’unica variante ammessa, per i più, era la birra rossa, creatura mitologica che vanta ancora nel XXI secolo un neppure troppo ristretto manipolo di fedeli adepti sicuri di riconoscerla con precisione in poche ma ben precise occasioni (che poi ciascuno degli adepti identifichi come la vera rossa qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri è una vasta questione che meriterebbe una trattazione a parte).
Per chi rifiutasse di principio l’abitudinarietà o fosse sinceramente interessato a capirne di più sulla spumosa bevanda, dunque, prelevare una Weizen dallo scaffale del supermercato o ordinarla in pizzeria, magari abbozzando pure un abbinamento con gli ingredienti della farcitura, era già un primo rilevante segno di differenziazione dalla massa.
Naturalmente gli irish pub, che colonizzarono in gran numero le nostre città nei primi anni Novanta, vennero accolti dai protogeek dell’epoca come una salvifica novità che permetteva di trascorrere delle serate in compagnia di birre nere come la pece spillate al carboazoto. Cionondimeno i veri oggetti di culto, in grado di suscitare sentimenti forti, a cavallo tra passione e perversione, e di far scoccare una scintilla in grado di infiammare i cuori, erano inequivocabilmente le birre belghe. Perché? Sicuramente perché si trattava di prodotti di qualità, specie se comparati con il resto dell’offerta, e si differenziavano nettamente dalla massa indistinta delle lager industriali da molti punti di vista. Proviamo a ricordarli insieme.
Il potere delle immagini: questione di etichetta
Etichette e nomi di un gran numero di specialità belghe risultavano all’epoca decisamente curiosi e attraenti, specie a fronte all’evidente piattume grafico e lessicale delle birre più mainstream, sovente commercializzate con il solo nome del produttore e un’etichettatura del tutto priva di immagini e guizzi creativi. Del resto le major lasciavano solo agli spot televisivi e alle inserzioni su carta stampata il compito di evocare uno scenario di consumo, anch’esso, peraltro, sovente trito, scontato e imperniato su pochi stilemi quali: spiaggia/falò/grigliata/ragazza bionda sorridente, graziosa e, strano a dirsi, disponibile, oppure nella variante partita in tv/gruppo di amici/bevuta dal collo della bottiglia con pietosa dissolvenza in nero a coprire il momento dell’inevitabile “rutto libero” di fantozziana memoria. A confronto, le immagini di pirati, bucanieri, briganti, diavoli e satanassi di ogni forma e colore, gnomi, elfi, streghe, elefanti rosa, cherubini, personaggi natalizi, remote abbazie, vetrate gotiche e pesci saltellanti che istoriavano (e ancora istoriano) le bottiglie di molte birre fiamminghe e valloni portavano per mano l’aspirante bevitore in una dimensione autenticamente evocativa ed onirica: prima ancora di berle, queste birre ci avevano già regalato sogni a occhi aperti in luoghi e tempi lontani.
Angeli e demoni: il fascino del proibito e la coincidenza degli opposti
La contrapposizione tra birre in odore di santità, che fossero autenticamente trappiste, più semplicemente “d’abbazia” o, anche soltanto caratterizzate da un’iconografia richiamante ambienti monastici o entità angeliche, e birre sataniche, segnate dalla presenza nel nome e nell’etichetta da creature infernali o da personaggi dalla professione canonicamente ritenuta incline alla malvagità, ha colpito l’immaginazione di qualunque appassionato della prima ora delle birre belghe. Il fascino del proibito, ai confini del sacrilego e del blasfemo, era inoltre acuito dalla constatazione che molto spesso i nettari dedicati ad angeli e demoni avessero caratteristiche tipologiche e organolettiche piuttosto simili.
Booze matters
Il grado alcolico da medio a decisamente elevato di queste birre ha avuto un innegabile ruolo nella costruzione della loro fama e di quella della nazione di provenienza. Ciò è avvenuto sia in relazione al punto precedente, dal momento che un considerevole tenore etilico era interpretato sia come scala a pioli per il paradiso, previe audaci visioni mistiche, che, all’opposto, come botola spalancata verso sfrenati baccanali e la conseguente perdizione, sia, in senso più lato, perché una birra forte attraeva inevitabilmente come una magnete l’attenzione dei bevitori più giovani, curiosi e a caccia di esperienze estreme. I ragazzi che negli anni Ottanta e Novanta bevevano Belgio perché non si accontentavano della “solita bionda” sono infatti divenuti in numero significativo birrai, degustatori e gli appassionati della prima generazione.
La parola al bicchiere: varietà, profondità e intensità
Etichette, nomi e ambientazioni hanno giocato un ruolo importante, certo, ma quando si tratta di birre l’ultimo e definitivo giudice è sempre il bicchiere e, pertanto, le ragioni del passato successo delle birre belghe vanno ricercate in primo luogo nelle caratteristiche organolettiche. Schiuma imponente, di lunghissima persistenza e, in caso di inaccorta mescita da bottiglia alla John Wayne, ovvero tutta d’un colpo senza lasciare al suo posto il fondo di lieviti, puntellata da arcane macchie brune che lasciavano perplesso il bevitore neofita; profumi intensi e opulenti di pera matura, pesca sciroppata, banana, noce, mandorla, pepe bianco o nero, coriandolo, scorze d’agrumi, pan pepato, datteri, cacao: già molto prima del primo sorso una belga faceva subito capire che non sarebbe stata la solita birra. L’utilizzo di spezie e altri ingredienti speciali e la grande creatività esibita dai birrai fiamminghi e valloni, ciascuno in grado di dare un’identità peculiare e inconfondibile alle proprie creature, sono state importanti chiavi per stimolare la curiosità dei bevitori e hanno avuto un notevole impatto anche nel plasmare la forma mentis della prima generazione di birrai artigiani italiani. Anche per chi avesse colpevolmente trascurato le componenti visive e olfattive, la sorpresa sarebbe comunque arrivata al gusto: sentori analoghi a quelli poc’anzi descritti su una trama in prima battuta dolce (senza mai sfociare però nella stucchevolezza, almeno nei migliori esemplari della specie) ma, soprattutto, dal carattere potente, con un’elevata persistenza anche nel retrogusto e retrolfatto. Uno schiaffo in pieno viso allo stereotipo della birra come bevanda leggera, amarognola, gustativamente poco intensa e, di conseguenza, adatta a un consumo disimpegnato: per un popolo devoto al vino come il nostro è del tutto plausibile che le grandi belghe ci abbiamo insegnato, tra le altre cose, che anche la birra merita di essere degustata con la dovuta attenzione e può riservare una nuova sorpresa a ogni sorso.
Una bevanda di culto merita dei templi
Considerate tutte queste premesse, non è certo sorprendente che i primi pub pionieristicamente votati alla birra di qualità e indipendenti dal filone irlandese poc’anzi citato avessero orientato sulle specialità fiamminghe e valloni la bussola della propria offerta. Il Delirium Tremens di Merate (LC), che arrivò addirittura troppo in anticipo sui tempi, il Peppo Bar di Colle Brianza (LC), il Woodstock e la Belle Alliance di Milano, l’Abbazia di Sherwood di Caprino Bergamasco (BG), lo Sherwood Music Pub di Nicorvo (PV), il Pub del Duca di Genova, la Brasserie La Loggia di Pisa, il Thomasbräu di Garlasco (PV), il Nidaba di Montebelluna (TV), la Brasserie del Camaleonte del compianto Franco Marini a Paratico (BS): ai banconi di tutti questi luoghi di culto, birra ricercata era, senza alcuna esitazione, sinonimo di birra belga. I più audaci e intraprendenti tra questi publican, inoltre, furono artefici di un fondamentale salto di qualità nella proposta: in assenza di realtà distributive che trattassero i produttori più piccoli e interessanti che il Belgio potesse offrire e facendo tesoro delle informazioni trasmesse dai primi divulgatori come Michael Jackson, John White, Stephen D’Arcy e il nostro Lorenzo “Kuaska” Dabove, i titolari e gestori di questi locali divennero “distributori di loro stessi” mettendosi al volante dei propri furgoni e andando ad attingere direttamente alla fonte. Fu così che i loro fortunati avventori ebbero l’opportunità di passare dalle più commerciali e “pettinate” Leffe, Affligem, Bonne Esperance, Maredsous, Floreffe, Duvel, Bosteels, alle ben più audaci e sorprendenti creazioni di birrifici come Dupont, De Dolle, Brasserie à Vapeur, Kerkom, Fantôme, Abbaye De Rocs, Rulles, Caracole, Malheur, Alvinne, De Struise, Ellezelloise, Ecaussines, Loterbol e altre ancora, nonché di scoprire le trappiste diverse da Chimay che per molti, chi vi scrive incluso, era stato il birrificio della svolta senza possibilità di ritorno.
Ascesa e declino
È in quest’epoca, nei primissimi anni Duemila, che si osservano anche due fenomeni alquanto significativi nonché profetici su quanto sarebbe avvenuto in futuro: da una parte l’ascesa e declino, nel cuore degli appassionati brassicoli, si intende, del marchio La Chouffe, passata in poco più di un lustro da specialità ambita e ricercata la cui presenza era una sorta di garanzia di qualità del locale che la servisse, a birra mainstream più presente sugli scaffali dei supermercati che nelle spine e nei frigoriferi dei pub specializzati, destino che sarà poi inevitabilmente condiviso dalle produzioni dei microbirrifici acquisiti dalle major, dall’altra la nascita del mito Westvleteren. La trappista meno prodotta e diffusa sul mercato e, di conseguenza, più ambita, è stata infatti la prima birra a generare liste d’attesa, appuntamenti e code di persone anelanti di poter ritirare la propria ristretta dose di nettare divino nonché il primo prodotto brassicolo a vedere la propria quotazione economica crescere in modalità esponenziale rispetto al prezzo originario praticato dal produttore. La WV 12, la più forte e richiesta delle tre sorelle dell’abbazia di Sint Sixtus, è stata la prima whale, come vengono chiamate oggi le etichette più rare e ambite sul mercato secondario.
Poi, lentamente, qualcosa è cambiato e la ruota ha invertito il suo giro, come sovente accade, proprio nel momento dell’apice del successo: il grande Belgio classico è stato infatti l’ispiratore di una significativa quota dei pionieri del movimento artigianale italiano, Baladin in testa. E proprio mentre le prime produzioni nazionali si conquistavano, con fatica e merito, il proprio spazio nelle spine dei pub e sugli scaffali dei beershop, il Paese della cuccagna birraria infilato tra Francia e Germania si mostrava con un nuovo e accattivante volto. L’alchimia tra ceppi di lievito belgi utilizzati in modo tale da contenere la produzione di esteri e fenoli e spingere invece verso una maggiore attenuazione degli zuccheri uniti a una più audace luppolatura, sia in amaro che in aroma, si era infatti rivelata come una delle novità più intriganti, promettenti e dalle solide radici che si potessero auspicare. La cronologia rivela che la prima birra imperniata su questi cardini è stata nientepopodimeno che la Arabier di De Dolle, anche se la XX Bitter di De Ranke ha poi decisamente avuto un maggior impatto sul mercato e, di conseguenza, nell’immaginario collettivo, ove è da sempre percepita come la pietra miliare del “nuovo Belgio”. Scoprire il lato amaro e il grado alcolico tutto sommato contenuto, si pensi alla Taras Boulba di De La Senne, altro birrificio simbolo della new wave fiamminga e che a De Ranke è storicamente legato a doppio filo, nelle birre belghe proprio nel momento in cui iniziavano a farsi largo nel nostro Paese le ale luppolate di matrice statunitense, sia importate che interpretate dai nostri microbirrifici, avrebbe potuto essere un viatico per mantenere sotto il dominio di Bruxelles sogni e desideri dei sempre più numerosi appassionati di birre di qualità.
Ma non è andata così: le American IPA nelle loro sempre più frequenti declinazioni e variazioni hanno conquistato lo scettro relegando il grande Belgio, sia vecchio che nuovo stile, ai margini. Perché? Anche in questo caso i fattori sono inevitabilmente molteplici. Il primo è schiettamente gustativo: se si sottopone a un dialogo socratico molti appassionati di birre luppolate di scuola americana si viene infatti a scoprire che ciò che amano in queste tipologie non è la componente amara ma i sentori di frutta a polpa gialla, tropicale, date dai luppoli, peraltro rafforzati da un residuo zuccherino più elevato rispetto alle belghe di nuova scuola. Non è infatti raro trovare bevitori compulsivi di Double IPA che rifiutano una XXX Bitter in quanto “troppo amara”. Per converso, la tendenza generale a prediligere birre molto più attenuate rispetto a uno o due decenni fa, oggi penalizza le belghe più di vecchio stampo (quando, di recente, ho riassaggiato dopo molti anni una Chouffe l’ho trovata incredibilmente più dolce di quanto la ricordassi). Il fattore immagine ha poi completamente mutato di valenza: in confronto alle grafiche innovative e sempre più aggressive proposte dai microbirrifici di tutto il mondo, specie dopo il boom delle lattine, le etichette dei classiconi belgi hanno oggi un sapore inequivocabilmente âgée quando non fanno addirittura tenerezza per l’antiquatezza di temi e tecniche illustrative. Anche il fascino dell’estremo e del proibito è, nel frattempo, venuto meno perché il mondo craft sforna oggi prodotti estremi e provocatori a ciclo continuo battendo territori gustativi completamente diversi: double e triple dry hopping, Imperial Stout con passaggi in botte e ingredienti aggiuntivi di ogni genere, sour, specie con uso di frutta. Proprio il Lambic e i suoi derivati rappresentano, non a caso, l’unica nicchia dell’arte birraria belga che abbia visto aumentare il proprio hype negli ultimi anni, ma questo è un argomento che meriterebbe una lunga trattazione a parte.
Se si abbandona la logica geek e si rivolge l’attenzione ai bevitori “ordinari” che si sono negli ultimi anni avvicinati alla birra artigianale e hanno contribuito a fornire una solida base di consumo alla rinascita delle lager, non assistiamo comunque a un consistente interesse verso le tipologie belghe, sia a causa dello stereotipo che le vede come forti e impegnative (il rovescio della medaglia di uno dei motivi della loro primigenia fama) sia perché, se si ha la sventura di incontrare una birra non esattamente al top della forma, finire un bicchiere di una birra in stile belga con esteri e fenoli fuori controllo e magari problemi di eccesso di sentori etilici rappresenta una sfida ben più ardua di una lager con un eccesso di solfuri o una punta di diacetile o ancora di una ale anglosassone con qualche problema di ossidazione o con un finale un po’ troppo astringente. Per noi che siamo birrariamente nati con il Belgio, però, aiutare i bevitori più giovani a riscoprirne la grandezza è un autentico dovere.