Vi svelo il mio libero approccio alla degustazione, parola di Kuaska
Sarebbe stupido fingere di negare la popolarità e la stima che un numero sempre crescente, tra gli adepti della prima ora che tra i nuovi arrivati, passando tra quelli intermedi, mi riconosce con affetto e sincerità, in presenza, sui social, negli eventi o tramite citazioni, riferimenti e pubblici riconoscimenti. Sarebbe inoltre stupido anche non ammettere che la cosa mi faccia piacere ma, credetemi, quello che veramente mi rende contento e realizzato è la consapevolezza di aver trasmesso sana passione e conoscenza senza aver mai snaturato la mia indole di poeta-alieno.

Sana passione e conoscenza sono due fattori fondamentali nella mia “missione per conto di Dio”, ma mentre sulla prima non ci piove, sulla seconda ritengo ci sia tanto da dire e su questo aspetto vorrei approfondire il mio libero-pensiero. Come spesso ho affermato galeotto fu il libro World Beer Guide, edito nel 1977, del mio compianto maestro Michael Jackson che oggi avrebbe solo 80 anni, che svegliò, grazie al capitolo sulle wild beer, quel demone interno al quale vendetti l’anima cinque anni dopo varcando la soglia della brasserie Cantillon ad Anderlecht, in rue Gheude 56.
Nel mio primo biglietto da visita, anni ‘90, rocambolescamente autoprodotto con stampante, immagini e smodato uso della casella di testo, inserii una mia foto, la bandiera del Belgio e la scritta “Belgian Beer Expert”. Biglietto recentemente ricomparso grazie a una delle meravigliose anziane cameriere del ristorante Drie Fonteinen che, da anni, lo conservava gelosamente in attesa di incontrarmi. Ovviamente, all’epoca, sapevo più di altri anche di birre anglosassoni, cecoslovacche e tedesche ma non mi sentivo un esperto di quegli specifici paesi mentre in Belgio ero già conosciuto a tal punto che il mio nome era già apparso in una rivista bilingue fiammingo-italiano dal titolo “Al dente” dedicata agli italiani emigrati. Non scrissi nemmeno “degustatore” perché, anche se avevo cominciato a studiare seriamente nel Regno Unito, non mi ritenevo tale dato che mi dedicavo più a far conoscere e raccontare di persone come produttori, assemblatori, gestori di locali, di beer shops nonché dei mille personaggi unici e talvolta bizzarri che quel piccolo paese mi regalava a getto continuo.
Ho appositamente menzionato il verbo “studiare” perché, come in ogni settore di conoscenza, non bastano una smisurata passione, un’irrefrenabile curiosità e un’infaticabile pratica sul campo, ma queste importantissime qualità vanno implementate su una solida base che solo lo studio può conferire ed assicurare. Ma che tipo di studio si poteva fare ai miei tempi? Libri? Quei pochi e difficili da reperire li avevo trovati e mangiati, ma andavano integrati con insegnamenti da persone autorevoli che la mia buona stella mi fece incontrare grazie a preziose dritte da parte dei miei primi colleghi del CAMRA che, adottandomi come una mascotte sin dal mio primo GBBF, mi indirizzarono a delle branch dello Yorkshire e poi dell’est di Londra, legate a istituti privati che organizzavano, a prezzi scontati, anche per membri del CAMRA, corsi di analisi sensoriale di bevande alcoliche, distillati vari, principalmente whisky, ma per fortuna anche di real ales.
Gli inizi furono molto duri per vari motivi. Per prima cosa, la lingua che non padroneggiavo bene oltretutto parlata velocemente e con accenti tremendi, specie quelli dei docenti scozzesi e irlandesi. Poi l’impostazione rigida e un po’ pomposa come le loro divise da college, con tanto di stemmi, su uomini di una certa età, quasi tutti con enormi pance, folte barbe e grossi baffi che si impregnavano di birra ad ogni sorsata. Magari personaggi un po’ ridicoli e anacronistici per un ex figlio dei fiori come me, ma ai quali devo tutto per avermi insegnato le basi sulle quali poi ho costruito, in modo naturale, il mio metodo di degustare e valutare le birre che mi ha portato, specie nell’ultimo quarto di secolo, a concentrarmi e lavorare sulle percezioni per poi inventare tecniche personali come “l’impressionismo” e “l’open mind”. Spesso mi si chiede perché io dica che debba tutto, come ho appena scritto, ai britannici e non ai belgi e la risposta mi viene diretta, senza esitazioni, costituita da due fattori decisivi.
Il primo deriva dalla sconfinata varietà di aromi e gusti che le birre belghe mi offrivano. Beh, non è forse meglio mi direste voi. In realtà quella varietà si trasformava in disomogeneità per un futuro degustatore che volesse crearsi le basi. Mi spiego: all’epoca ogni area, non dico provincia ma proprio area, aveva birre particolari, uniche, che non trovavi al di fuori, per non parlare di quelle dei singoli villaggi che avevano la loro birra, passatemi il termine, localissima. Tutte diversissime: le scure e dolcissime stout, come la Louwaege di Kortemark e soprattutto la Wilson Mild di Bios, oltrepassanti la sopportazione della stucchevolezza; le scure ma più secche come la Callewaert di Zwevezele; le dorate e amare, come la Arabier di Esen e la Kerelsbier di Boezinge; le scure acidule di Oudenaarde; le rossicce acetiche di Roeselare; le acide con e senza frutta del Pajottenland; le agrumate e speziate di Hoegaarden; le maltate di Anversa che aveva pure una nota fumée; le rustiche, a volte molto rustiche, dell’Hainaut; e così via.
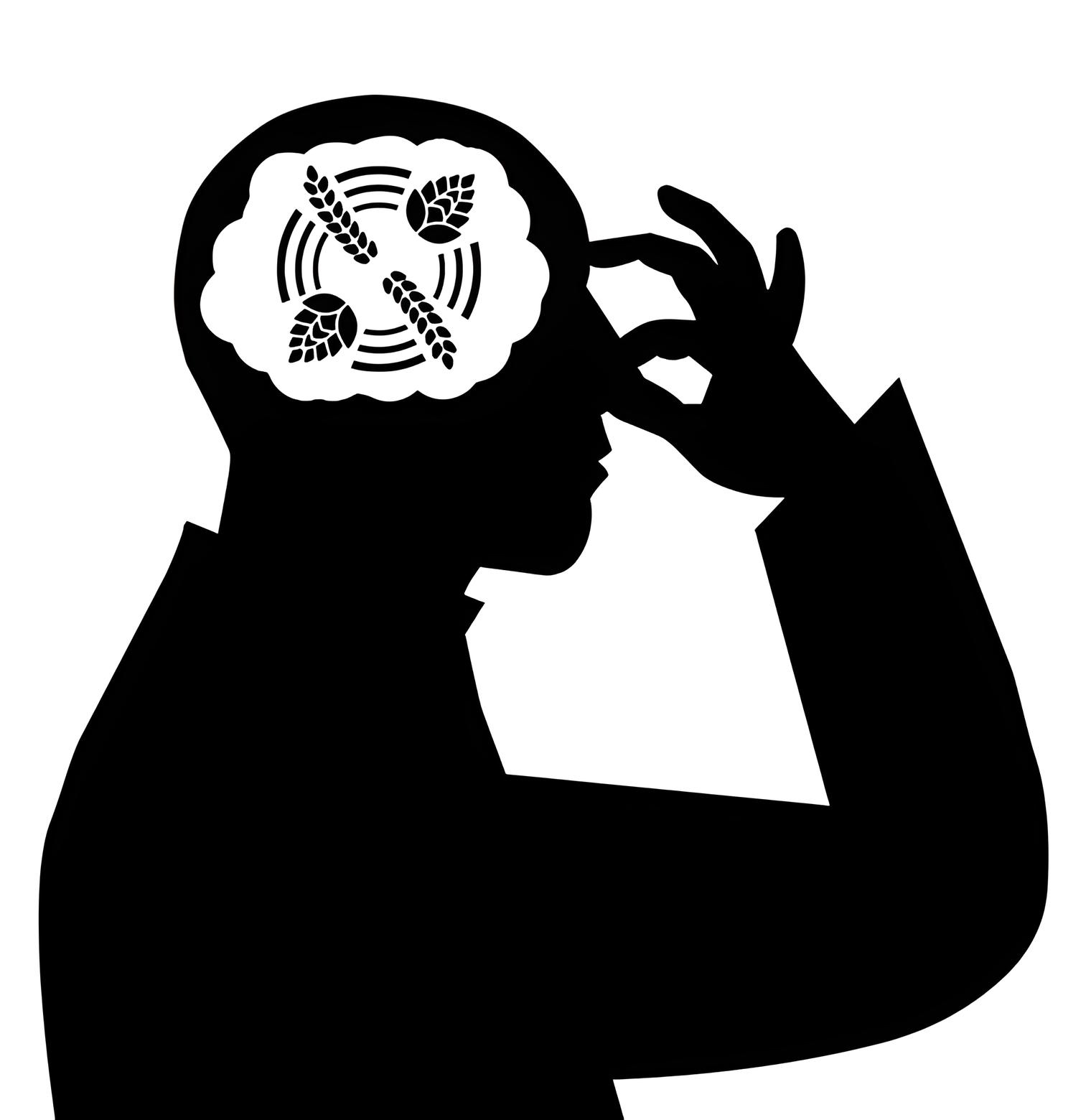 Il secondo fattore, molto importante e legato a quanto detto del variegato panorama belga, fu quello che mi aprì occhi e mente, quando mi trovai davanti per la prima volta, dopo tante pesanti lezioni di sola teoria, un panel di degustazione con una dozzina di best bitter. Annusandole e poi assaggiandole sembravano, al primo approccio, tutte uguali ma poi, con l’esercizio e le tecniche apprese, trovai facilmente quelle lievi differenze, quel minimo gap, distinguendo l’una dall’altra. Come avrei potuto farlo con le belghe così diverse tra loro?
Il secondo fattore, molto importante e legato a quanto detto del variegato panorama belga, fu quello che mi aprì occhi e mente, quando mi trovai davanti per la prima volta, dopo tante pesanti lezioni di sola teoria, un panel di degustazione con una dozzina di best bitter. Annusandole e poi assaggiandole sembravano, al primo approccio, tutte uguali ma poi, con l’esercizio e le tecniche apprese, trovai facilmente quelle lievi differenze, quel minimo gap, distinguendo l’una dall’altra. Come avrei potuto farlo con le belghe così diverse tra loro?
Tenete sempre conto dell’epoca. Oggi sarebbe apparentemente più facile, per fare un esempio, con dubbel e tripel ispirate alle caposcuola. Facilissimo purtroppo con le belgian IPA che rischiano di snaturare il patrimonio della mia seconda patria. Ecco perché oggi, nella veste di docente, esorto gli allievi ad esercitarsi e allenarsi con panel di birre apparentemente molto simili, in primis le Münchner helles. Mi è sempre piaciuto insegnare e nel corso del tempo ho maturato un convincimento riguardo il ruolo del docente che espongo agli allievi all’inizio di ogni corso o singola lezione. Essendo impossibile approfondire al massimo tutti gli argomenti facenti parte di un programma, io suggerisco di lasciarsi conquistare da un tema specifico che poi, specie oggi che si dispone della rete e delle tecnologie, ogni allievo potrà approfondire e scavare sorretto dalla curiosità e desiderio di saperne il più possibile. Questo stimolo può venire dalla competenza del docente e dalla sua capacità di saper divulgare e coinvolgere gli studenti o, al contrario, dall’insoddisfazione di questi ultimi che li spinga a contestare metodi applicati o ideologie non condivise.
Questa intuizione mi venne da un illustre professore che collaborava alla rivista scientifica in cui lavoravo, ritenuto a ragione il maggior esperto del neutrino. Mi disse che la scintilla gli arrivò, da studente, durante una lezione di fisica all’Università proprio per la bravura del docente nell’esporre il concetto e nella sua onesta ammissione a non poter sviscerare completamente quella specifica materia per mancanza di tempo dovuta a un programma troppo grande e variegato. La scintilla ormai era scoppiata e quello studente diventò il massimo esperto di neutrino! Da sempre nemico dei tuttologi, sono un grande estimatore di chi sia molto competente in quello che sappia e che non si avventuri in quello che sappia meno. A me successe qualcosa di simile durante le lezioni dei miei primi insegnanti britannici. Tra formule chimiche, grafici e misurazione di livelli, fui particolarmente colpito, in tema di esteri, da paroline tipo “Isoamyl acetate” e Ethyl hexanoate” che mi spaventavano non poco ma che poi al momento delle annusate, scoprii fossero molto semplici e facili da percepire e definire come banana e mela.
Se sulla banana, non avevo dubbi a definirla matura mentre sulla mela non ero per nulla convinto diventando pazzo ad ogni annusata che facevo, nella mia stanza, dalla dannata provetta con la scritta “Eth.Hex” finché, per trovare una soluzione, mi inventai una cosa che poi diventò una mia caratteristica, andare in “trance” e cogliere un aroma di riferimento che di solito risale all’infanzia o all’adolescenza. Trovai così quell’agognato riferimento nel ghiacciolo azzurro che da piccolo mi attirava ma il cui gusto non amavo poi tanto. Trionfante esclamai, da solo, “anice!” Senza rendermene conto avevo sperimentato, per la prima volta, qualcosa che potessi definire farina del mio sacco dopo che avevo sempre sfruttato, per l’apprendimento, farine di sacchi altrui. Stava nascendo in me quel libero-pensiero sulla degustazione, non solo a livello teorico ma soprattutto pratico con esercizi divertenti, coinvolgenti e stimolanti.




