Italian Style: esiste la birra italiana?
 Esiste la birra italiana? La domanda sembrerebbe banale e la risposta evidente, lapalissiana. Certo che esiste, la birra italiana! Abbiamo più birrifici del Belgio, i nostri prodotti sono stimati dagli appassionati di mezzo mondo, produciamo birre molto originali e innovative. Tutto vero, senz’altro. Da una decina d’anni il fenomeno dei microbirrifici ha cambiato notevolmente il panorama birrario italiano: non avendo una grande tradizione storica molti produttori hanno iniziato con una netta ispirazione ai grandi classici mondiali, con risultati che negli anni sono stati notevolissimi. Si pensi all’eclatante (e per certi versi bizzarro) risultato della Tipopils del Birrificio Italiano, che da un po’ di tempo domina la classifica mondiale delle pilsner su ratebeer, superando tutti i classici cechi e tedeschi.
Esiste la birra italiana? La domanda sembrerebbe banale e la risposta evidente, lapalissiana. Certo che esiste, la birra italiana! Abbiamo più birrifici del Belgio, i nostri prodotti sono stimati dagli appassionati di mezzo mondo, produciamo birre molto originali e innovative. Tutto vero, senz’altro. Da una decina d’anni il fenomeno dei microbirrifici ha cambiato notevolmente il panorama birrario italiano: non avendo una grande tradizione storica molti produttori hanno iniziato con una netta ispirazione ai grandi classici mondiali, con risultati che negli anni sono stati notevolissimi. Si pensi all’eclatante (e per certi versi bizzarro) risultato della Tipopils del Birrificio Italiano, che da un po’ di tempo domina la classifica mondiale delle pilsner su ratebeer, superando tutti i classici cechi e tedeschi.
Come gli appassionati sanno bene, però, i nostri birrai non si sono limitati a riprodurre con sapienza gli stili classici, ma sono andati ben oltre, attingendo alla classica “fantasia” italiana: sono nate eccellenti birre alla frutta (ciliegie, chinotti, pesche, mirtilli, melograni, gelsi…), con cereali insoliti (miglio, avena, segale, farro, grano saraceno, amaranto…), spezie (curry, genziana, ruta, mirra, vaniglia, bava del larice…), oppure maturate in legno, a fermentazioni miste; sembra non ci sia limite alla creatività dei nostri birrai, oltre che alla loro padronanza tecnica: si tratta spesso di birre molto originali, ma quasi sempre anche molto corrette, dove la caratterizzazione è ben armonizzata con le altre caratteristiche organolettiche. Sono comunque birre che si bevono molto volentieri. Eppure, nonostante tutto quanto detto fin qui, credo che la domanda iniziale, se letta più in profondità, possa avere una risposta negativa. La birra “italiana” non esiste! Non esiste se per “italiana” intendiamo “autoctona”, “riconoscibile”, a “denominazione di origine protetta”.
Ogni appassionato sa riconoscere ad occhi chiusi la provenienza delle birre, almeno per quanto riguarda gli stili classici: impossibile non riconoscere il bouquet di una belga d’abbazia, oppure il luppolo di una ale americana, o ancora le note di una bitter inglese o l’erbaceo di una keller bavarese. Nei paesi di grande tradizione birraria (essenzialmente Belgio, Germania e Inghilterra) si sono codificate, nei secoli, una serie di metodologie di lavoro e una gamma di materie prime che definiscono in modo spesso inequivocabile la “territorialità” delle birre. Penso, ad esempio, al single step o al dry-hoppying molto diffusi nel Regno Unito o alla decozione utilizzata spesso in Germania. Oppure alla caratterizzazione di alcuni malti inglesi, o dei luppoli tedeschi, o all’uso tradizionale delle spezie in Belgio. O, ancora, si pensi alla timbrica che hanno molti lieviti valloni: in questo caso i ripetuti “scambi” di lieviti da un birrificio all’altro, molto frequenti nei secoli andati, hanno dato origine ad un vero e proprio “terroir” nella birra finita, in cui gli esteri della fermentazione donano un profilo assolutamente riconoscibile ed immediatamente identificabile.
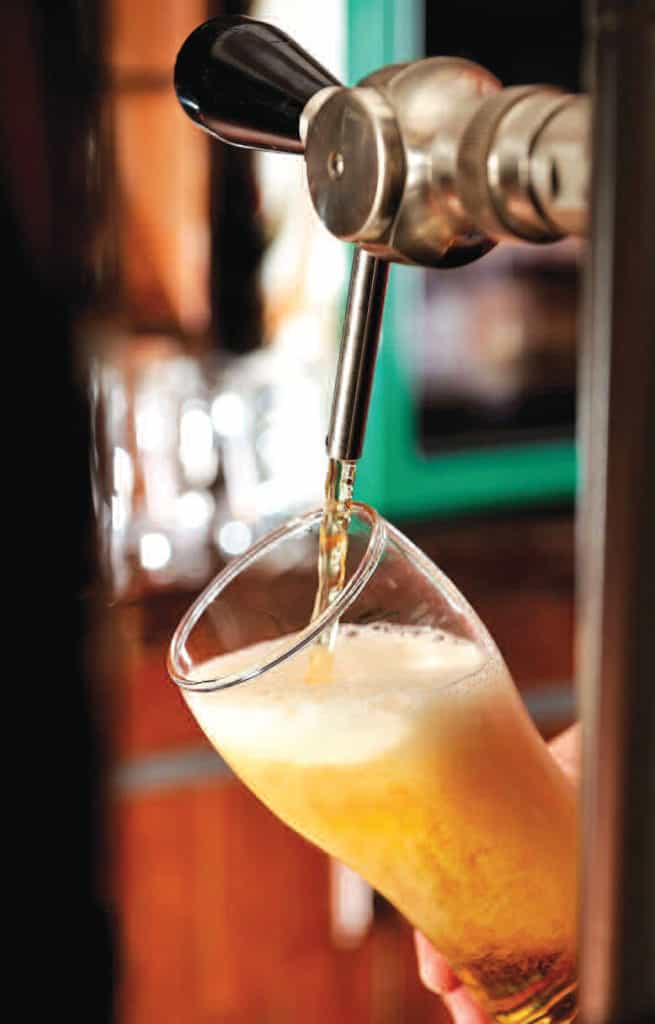 E in Italia? Ancora poco, pochissimo. A livello di tecnica, non avendo una storia comune, i nostri birrai hanno percorso praticamente tutte le strade possibili: abbiamo moltissimi tipi diversi di impianti e utilizziamo molte metodologie produttive. Le materie prime, invece, sono ancora spessissimo di provenienza estera, a parte, ovviamente, l’acqua (comunque molto importante per il risultato finale); questo da un certo punto di vista aumenta la diversità dei nostri prodotti, ma ci sono almeno un paio di questioni sulle quali sarebbe opportuno riflettere. Intanto c’è un’evidente questione di natura ecologica, legata alla sostenibilità ambientale. Un prodotto di eccellenza gastronomica non dovrebbe derivare da materie prime che attraversano tutta l’Europa: ovviamente questo è tanto più importante quanto aumenta il volume e il peso delle materie prime; certo vale poco se si sta parlando di qualche grammo di spezie, ma diventa importantissimo quando sono in gioco molti quintali di malto d’orzo. E non basta che le materie prime siano nazionali, ma sarebbe auspicabile che fossero locali, al più regionali (da Piozzo a Melfi ci sono quasi mille chilometri, è più vicina Bamberga…).
E in Italia? Ancora poco, pochissimo. A livello di tecnica, non avendo una storia comune, i nostri birrai hanno percorso praticamente tutte le strade possibili: abbiamo moltissimi tipi diversi di impianti e utilizziamo molte metodologie produttive. Le materie prime, invece, sono ancora spessissimo di provenienza estera, a parte, ovviamente, l’acqua (comunque molto importante per il risultato finale); questo da un certo punto di vista aumenta la diversità dei nostri prodotti, ma ci sono almeno un paio di questioni sulle quali sarebbe opportuno riflettere. Intanto c’è un’evidente questione di natura ecologica, legata alla sostenibilità ambientale. Un prodotto di eccellenza gastronomica non dovrebbe derivare da materie prime che attraversano tutta l’Europa: ovviamente questo è tanto più importante quanto aumenta il volume e il peso delle materie prime; certo vale poco se si sta parlando di qualche grammo di spezie, ma diventa importantissimo quando sono in gioco molti quintali di malto d’orzo. E non basta che le materie prime siano nazionali, ma sarebbe auspicabile che fossero locali, al più regionali (da Piozzo a Melfi ci sono quasi mille chilometri, è più vicina Bamberga…).
E poi c’è una ragione legata alla caratterizzazione “nazionale” del prodotto: ritengo che sia necessario iniziare a pensarci, i birrai più lungimiranti lo stanno già facendo. Un’esperienza concreta è quella, interessantissima, della Sticher del Grado Plato: Sergio Ormea ha portato avanti un progetto, assieme con il locale Istituto Agrario, sulla produzione del malto e sulla coltura del luppolo che ha grandi potenzialità. Molto ci si aspetta, su questo tema, dal Baladin: già da tempo Teo Musso ha introdotto il concetto di “filiera controllata”, per evidenziare la provenienza delle materie prime. Attualmente sta lavorando ad un paio di progetti sulle materie prime locali, stiamo a vedere. Così come molto interessante è l’esperienza di Andrea Bertola (ex Troll, attualmente alle prese con altri pensieri, sempre birrari), che ha messo a dimora una classica varietà tedesca di luppolo nelle campagne cuneesi. Con la prima raccolta è stata realizzata una birra, che ho potuto assaggiare: incredibile come il luppolo abbia già evidenziato, rispetto allo stesso prodotto tedesco, un carattere molto diverso, nuovo, mai sentito.
Sono solo tre nomi. Ce ne sono sicuramente altri, che non conosco, ma sono il segno che qualcosa sta succedendo. Così come una dozzina di anni fa sono nati, improvvisamente, una manciata di birrifici, c’è la possibilità che qualcosa si concretizzi in questa direzione. I nostri birrai (una parte di loro, almeno) hanno ampiamente dimostrato di saperci fare: hanno solo bisogno degli ingredienti giusti. Credo che questa sia la scommessa dei prossimi dieci anni, che rappresenti la prova della compiuta maturità del movimento. Sono assolutamente convinto che, così come è successo non molti anni fa negli Stati Uniti, si possa, anche in Italia, venire ad avere materie prime che possano dare origine ad uno vero e proprio Italian Style, che ci caratterizzi in mezzo al mare magnum delle grandi birre mondiali. Qualcosa si sta già muovendo…





Mi conforta pensare che i capofila della nouvelle vague birraria italiana siano fortemente attenti alla provenienza delle materie prime e alla sostenibilitàdella filiera: malti e luppoli locali, zucchero del commercio equo.. Queste birre aspirano davvero ad essere sempre più “buone” ma anche pulite e giuste (così tanto per scomodare e logorare ulteriormente lo slogan Slow)
articolo molto interessante…
Queste sono notizie che tutto il popolo italiano dovrebbe sapere, così da accrescere ancora maggiormente, la voglia dei nostri “paladini di Cerere” di produrre oltre che per l’Italia anche per gli italiani tutti, che possano così andare fieri non più soltanto dei magnifici vini nostrani, provenienti dalle rispettive vigne, ma anche delle giovani produzioni brassicole nazionali provenienti dalle NOSTRE rispettive neo-filiere.
Ma in italia si possono produrre materie prime di qualitàelevata?
E poi, l’Italia presenta notevoli differenze regionali e locali, si può davvero arrivare ad una identitàcomune? sono dubbioso
Sicuramente mi farebbe piacere sapere di una birra che acquisto oltre al luogo di produzione anche la provenienza delle materie prime, birra italiana fatta con orzo, luppolo e livito italiani sarebbe un bel biglietto da visita rispetto ad ipotizzare un mix di provenienze non ben specificate
Un bel articolo che solleva una riflessione interessante.Inoltre vorrei porre una domanda: per la birra è prevista dalla normativa europea un marchio di qualitàdi prodotto (come il vqprd per i vini e il dop per i prodotti agroalimentari) e se la birra può avvicinarsi più alla normativa vigente per i vini o per i prodotti agrolimentari?
Grazie