Pare ieri a pensarci, invece sono già passati quasi due anni da quando scorrevi la timeline di Facebook e ti imbattevi molto facilmente in qualcuno dei tuoi connazionali birrofili che pubblicava l’immagine di una New England IPA non certo per lodarla, ma gridando allo scandalo a causa della loro torbidità e opalescenza, il più delle volte modellata a colpi di filtri Instagram e Photoshop. Fondazza, vomito, erano le parole più gettonate, quasi un O tempora, O mores! contro un presunto malcostume generale che avesse afflitto il proprio piccolo recinto fatto di certezze e birre cristalline. Nonostante tutto, una discreta attenzione verso il fenomeno (già imperante e consolidato in America) si era manifestata nel nostro paese: l’interessante e divertente simposio durante l’edizione 2016 di Eurhop e gli infiniti dibattiti sul gruppo Facebook “Analfabeti della Birra” diedero linfa vitale alle diverse interpretazioni della corrente che seguirono da parte di alcuni dei più intraprendenti birrifici italiani.
Vento Forte fece centro quasi subito, realizzando quelli che forse tuttora restano i migliori esempi di NE IPA mai visti nel nostro paese e quasi alla pari coi grandi nomi statunitensi; Marco Valeriani di Hammer già da diversi mesi aveva cominciato a studiare il comportamento dei lieviti Conan/Vermont, e lo sfruttò a modo suo in birre come la Killer Queen e una Workpiece: American IPA, restando legato ad una delle sue grandi muse ispiratrici, ovvero quel birrificio riconosciuto tra i padri fondatori della scuola di oggi: Alchemist; i ragazzi di MC77 tirarono fuori la Velvet Suit, all’inizio per me incerta e poco aderente, ma migliorata di volta in volta fino ad essere oggi un validissimo esemplare nel campo; CrAk andò dritto al punto chiamando una loro nuova birra NE IPA, forti anche di trasferte statunitensi direttamente alla fonte in Massachusetts e Vermont; e last-but-not-least, Ritual Lab – come a voler sbattere il pugno sul tavolo per mostrare a chiunque di che pasta fossero fatti – sfornò la versione “juicy” di una delle loro migliori creazioni, la Nerd Choice. È logico che potremmo proseguire a lungo e citare tanti altri, ma lo scopo che mi ero prefisso non era un algido censimento, bensì partire dall’analisi dello stato dell’arte delle tendenze Made-in-NE-IPA in Italia, per poi ampliare il raggio geografico.
Quindi: si può dire che siamo stati grossomodo ricettivi nei confronti delle NE IPA. Abbiamo dato dimostrazione di saper offrire delle ottime birre, tra chi le ha sapute far aderire agli archetipi e chi si è invece cimentato in libere (a volte troppo) interpretazioni. Eppure: sembra finita lì. Sembra che la percezione di parecchi sia stata comunque quella di una banale moda passeggera, da provare giusto perché era sulla bocca di tutti, e poi Amen. Un tiepido entusiasmo, mai davvero acceso, o al massimo un fuoco di paglia. Prestando una minima attenzione alle opinioni comuni, se ne leggono tante: chi ascrive la floridezza e la popolarità delle NE IPA in gran parte ad una conseguenza dovuta giusto ai social media, in particolare Instagram e il suo renderle fotogeniche con bicchieri e filtri ad hoc; chi le trova stancanti e dalla difficile bevuta; chi le associa in automatico a quell’effetto “verde” dato da altissime e incontrollate concentrazioni di luppolo; chi le continua a ritenere birre di bassa lega, ancorandosi a una convinzione da basso medioevo difficile da eradicare – ovvero che le IPA in generale rappresentano il tipico prodotto per il ragazzino in cerca di amaro e mouthfeel più intensi che mai. Inutile dire che mi trovo completamente in disaccordo con simili opinioni. Sono invece in linea con quanto scrive Neil Fisher, head brewer di Weldwerks, birrificio del Colorado tanto apprezzato dai geek. Penso che il suo articolo “Unlock the secrets of New-England style IPAs” uscito ormai un anno e quattro mesi fa, sia una specie di manifesto. Cito: “[…] mi sono reso conto che alcune convenzioni brassicole sono più difficili da cambiare rispetto ad altre. Sembra che ad oggi l’aspetto, e specialmente la trasparenza, sia in cima alla lista di quelle cose da non cambiare mai secondo tantissimi birrai affermati ed esperti che io ammiro e rispetto. Per questo mi sono trovato in una posizione difficile, essendomi innamorato di uno stile che trascura completamente la chiarezza, ma che spinge la birra verso nuovi terreni”. Neil ci dice in sostanza che fermarsi all’aspetto torbido come primaria caratteristica del segmento è una considerazione superficiale; si tratta piuttosto di una conseguenza, non di un obiettivo da raggiungere. Nel dettaglio, Neil traccia quelle che secondo lui sono le linee di confine che delimitano la geografia delle NE IPA: malti ad alto contenuto proteico, utilizzo di avena e frumento, scelta di luppoli fruit-forward, lieviti poco attenuanti e flocculanti e tendenti a una ricchezza di esteri, trattamento dell’acqua per ottenere una maggiore concentrazione di cloruro rispetto ai valori di norma per un’IPA, contenere l’amarezza diminuendo le dosi di luppolo in bollitura e aumentandole nel whirpool, adottare differenti tecniche di dry-hopping e applicarle anche in fase di fermentazione. Ciascuno di questi punti viene spiegato nel profondo, precisando che variazioni sul tema sono ben accette a seconda del risultato desiderato. È una lettura che ho trovato affascinante, reperibile in rete su Beer&Brewing Magazine e che consiglio a tutti coloro che volessero ottenere una cognizione più solida del tanto chiacchierato ambito delle NE IPA; l’articolo chiude infine con la ricetta della Juicy Bits di casa Weldwerks, per chiunque volesse cimentarsi con l’homebrewing.
L’aspetto più bello della birra, comunque, resta l’aggregazione. Di culture, persone, azioni e pensieri diversi tra loro, ma con una passione (e un lavoro) in comune. Cito: “Credo che il successo delle NE IPA sia dovuto in buona parte al loro aspetto. […] Fino a poco tempo addietro la torbidità era considerato un osceno errore stilistico, adesso è un tratto distintivo visuale di uno stile, un marchio da desiderare […] fino al punto di diventare un meme della rete”. Questa frase sibillina è di Jason Synan: co-fondatore di Hudson Valley, piccolo birrificio dell’omonima regione a nord di New York, una delle realtà più interessanti negli ultimi due anni. Attivi dalla fine del 2016 dopo tanta sperimentazione non commercializzata, il loro nome è presto salito alla ribalta per la incredibile e stravagante capacità di mescolare stili e ingredienti fra loro con una leggerezza fuori dagli schemi. Volete un esempio? La Ultrasphere: sour IPA con lattosio, lamponi, Citra, Simcoe e Mosaic. Il cuore del loro lavoro risiede nelle 130 botti da cui attingono “come una scatola di pastelli; ciascuna delle botti rappresenta un colore […] e vogliamo che il prodotto finito rifletta gli strati del processo adottato per ottenerlo: creativo, tecnico, ragionato e gradevole. […] Non avendo delle linee guida, nel tempo il nostro lavoro è diventato di conseguenza eccentrico. La Ultrasphere ne è un esempio: […] da un punto di vista dello stile, si trova in un contesto talmente piccolo che persino commercialmente ha poco senso definirlo. E quando la versi nel bicchiere, ti rendi conto che non ce n’è affatto bisogno” – dice Jason. In buona sostanza, in contrapposizione a quanto detto sopra, da Hudson Valley non si scrivono ricette, ma blendano ciò che si ottiene alla fine dei vari processi di barrel-aging. Il loro curioso modus operandi è guidato da una solida consapevolezza dei prodotti di partenza e di una costante analisi dell’evoluzione di ogni singolo passaggio in botte. Ultrasphere a parte, le sour IPA non le hanno certo inventate loro, ma la particolarità qui è che non si parte dalla tecnica del kettle sour – diversamente da come si usa fare di solito. Il procedimento consiste nell’effettuare il blend di una “normale” IPA con alcune sour delle botti: “utilizziamo il carattere del luppolo come una componente del blend, come tutto d’altronde. È un altro pastello”. Un paio di mesi fa ho avuto l’occasione di provare una buona palette dei prodotti di Hudson Valley, e devo dire che, sebbene sulla carta la costruzione suoni bizzarra, l’esame del bicchiere è risultato più che positivo nella maggioranza dei casi. La Ultrasphere mi è piaciuta molto, ne ho apprezzato il carattere di bevibilità altissimo e il sapore grossomodo inusuale che richiama una bevanda rinfrescante senza sfociare nell’artificioso da bibita di scaffale dell’Autogrill. E mi ha sorpreso la percezione del lattosio: bassa, non avvolgeva il palato, né comprometteva la voglia del sorso successivo. C’era poi la Mirrorshield, sour IPA con frumento non maltato, malto d’avena, lattosio, lychee, camomilla e lavanda: dannatamente complessa e pulita, aspra, fresca, ricca di sapori e priva dell’effetto da bustina in infusione. Ciò che accomuna i migliori lavori di Hudson Valley è la facilità di bevuta, ti pare di aver fatto un sorso ed è praticamente già finita. Frontiere strane, eppure davvero piacevoli.
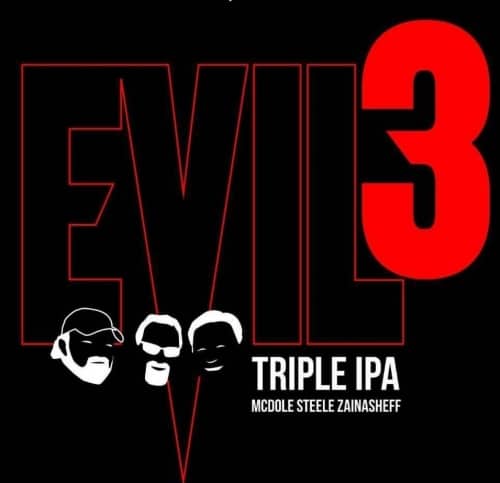 Ritengo che l’esplosione delle NE IPA abbia messo in moto un meccanismo di (ri)scoperta di vecchi e nuovi territori. Uno di questi è quello delle Triple IPA, che dalla definizione vien da pensare come qualcosa che vada oltre le Double IPA – specie in termini di gradi alcolici, dai dieci a salire. Qualche geek di lunga data potrà ricordare alcune esponenti della categoria importate da noi almeno sei anni fa: la Hop Dam Triple di Hoppin Frog e la Double Crooked Tree di Dark Horse, a cui aggiungerei la californiana Evil^3 di Heretic. In linea di principio erano prodotti di raffinata cafoneria (in senso buono), ottenuti con una regola piuttosto semplice: esasperare una ricetta, se non limitandosi strettamente a raddoppiare la quantità degli ingredienti (la descrizione ufficiale della Double Crooked Tree dice proprio questo). L’aumento esponenziale del malto si trasferiva nel corpo della birra rendendolo massiccio, poderoso, imponente, capace di fornire persino un buon invecchiamento; e il luppolo faceva sì la sua parte, ma era un contraltare. L’effetto finale non era tanto dissimile da quello di un American Barley Wine, meno complesso e che potremmo riassumere a grande velocità: ingresso dolce dalla robusta impronta maltata, lunga uscita amara e secca, il tutto pervaso da un tenore alcolico di una certa importanza. Birre così si producono ancora, ma non hanno mai avuto tanto successo. Con l’avvento delle NE IPA è scattata una molla e, oggi, parlare di TIPA ha più senso di prima, e non mi sorprenderei se il BJCP lo inserisse prossimamente nelle sue Guidelines. Lavorare con certe materie prime e tecniche permette, per dirla con Luke Skywalker, quello che io definisco “il bilanciamento della forza”: si punta a mantenere la morbidezza del corpo, arricchendo sicuramente l’ampiezza e la portata del mouthfeel, ma senza far recepire la botta alcolica con l’effetto di un pugno al palato. Negli Stati Uniti è da un annetto che stanno emergendo queste grosse creature, e il birrificio che finora ha dato prova di maggiore bravura è senz’altro The Veil. Se poi volete assaggiare qualche espressione di validissima fattura del campo, senza dover ricorrere al trade, abbiamo in Europa Northern Monk e Cloudwater che di tanto in tanto sfornano TIPA.
Ritengo che l’esplosione delle NE IPA abbia messo in moto un meccanismo di (ri)scoperta di vecchi e nuovi territori. Uno di questi è quello delle Triple IPA, che dalla definizione vien da pensare come qualcosa che vada oltre le Double IPA – specie in termini di gradi alcolici, dai dieci a salire. Qualche geek di lunga data potrà ricordare alcune esponenti della categoria importate da noi almeno sei anni fa: la Hop Dam Triple di Hoppin Frog e la Double Crooked Tree di Dark Horse, a cui aggiungerei la californiana Evil^3 di Heretic. In linea di principio erano prodotti di raffinata cafoneria (in senso buono), ottenuti con una regola piuttosto semplice: esasperare una ricetta, se non limitandosi strettamente a raddoppiare la quantità degli ingredienti (la descrizione ufficiale della Double Crooked Tree dice proprio questo). L’aumento esponenziale del malto si trasferiva nel corpo della birra rendendolo massiccio, poderoso, imponente, capace di fornire persino un buon invecchiamento; e il luppolo faceva sì la sua parte, ma era un contraltare. L’effetto finale non era tanto dissimile da quello di un American Barley Wine, meno complesso e che potremmo riassumere a grande velocità: ingresso dolce dalla robusta impronta maltata, lunga uscita amara e secca, il tutto pervaso da un tenore alcolico di una certa importanza. Birre così si producono ancora, ma non hanno mai avuto tanto successo. Con l’avvento delle NE IPA è scattata una molla e, oggi, parlare di TIPA ha più senso di prima, e non mi sorprenderei se il BJCP lo inserisse prossimamente nelle sue Guidelines. Lavorare con certe materie prime e tecniche permette, per dirla con Luke Skywalker, quello che io definisco “il bilanciamento della forza”: si punta a mantenere la morbidezza del corpo, arricchendo sicuramente l’ampiezza e la portata del mouthfeel, ma senza far recepire la botta alcolica con l’effetto di un pugno al palato. Negli Stati Uniti è da un annetto che stanno emergendo queste grosse creature, e il birrificio che finora ha dato prova di maggiore bravura è senz’altro The Veil. Se poi volete assaggiare qualche espressione di validissima fattura del campo, senza dover ricorrere al trade, abbiamo in Europa Northern Monk e Cloudwater che di tanto in tanto sfornano TIPA.
Diamo infine un’occhiata a quanto accade in California, dove, nello stato che ha dato i natali alle prima IPA in assoluto, la gente non è rimasta a guardare. Tralasciando il caso di Monkish, che ha saputo coniugare lo storico segmento delle West-Coast con le NE IPA con dei risultati di livello stellare e quasi inimitabili, durante il primo quadrimestre del 2018 l’interesse locale si è accentrato verso le Extra Brut IPA. Chiamate anche Hop Champagne, in totale controtendenza rispetto alle NE IPA, queste birre sono caratterizzate da alta carbonazione, corpo leggero e finale molto secco. L’idea consiste nello sfruttamento degli zuccheri residui per permettere una lavorazione a fondo dei lieviti e garantire, oltre che una secchezza pronunciata, un aumento della gradazione alcolica – ad esempio, la Et Tu Brut? di Bike Dog (Sacramento) viaggia sugli 8.5 ABV. Le prospettive di questa nuova trovata hanno certamente del potenziale, in quanto uniscono un carattere leggero alla robustezza alcolica, svuotando e rivoltando il concetto di Session IPA. Non c’è tanta diffusione e sono molto curioso di assaggiarle, nonostante mi pongo qualche domanda sulla reale efficacia (e il rischio) di un corpo troppo alleggerito in termini di mouthfeel. In Italia, comunque, abbiamo Carrobiolo che ha presentato da poco la Cuvee Tu Quoque, ispirata proprio alle EBIPA.
La vastità del terreno su cui le IPA si sviluppano permette quindi sperimentazioni, avanguardie, ritorni alle origini, contrappunti, che danno l’idea di un mondo in continuo movimento e avvezzo ai mutamenti. E invece di criticarne gli effetti indesiderati, tra mode e isterie collettive che spesso lasciano perplessità, preferisco continuare pensare che il mondo delle IPA sia e continui ad essere la migliore palestra per avvicinare nuovi consumatori all’universo craft.





