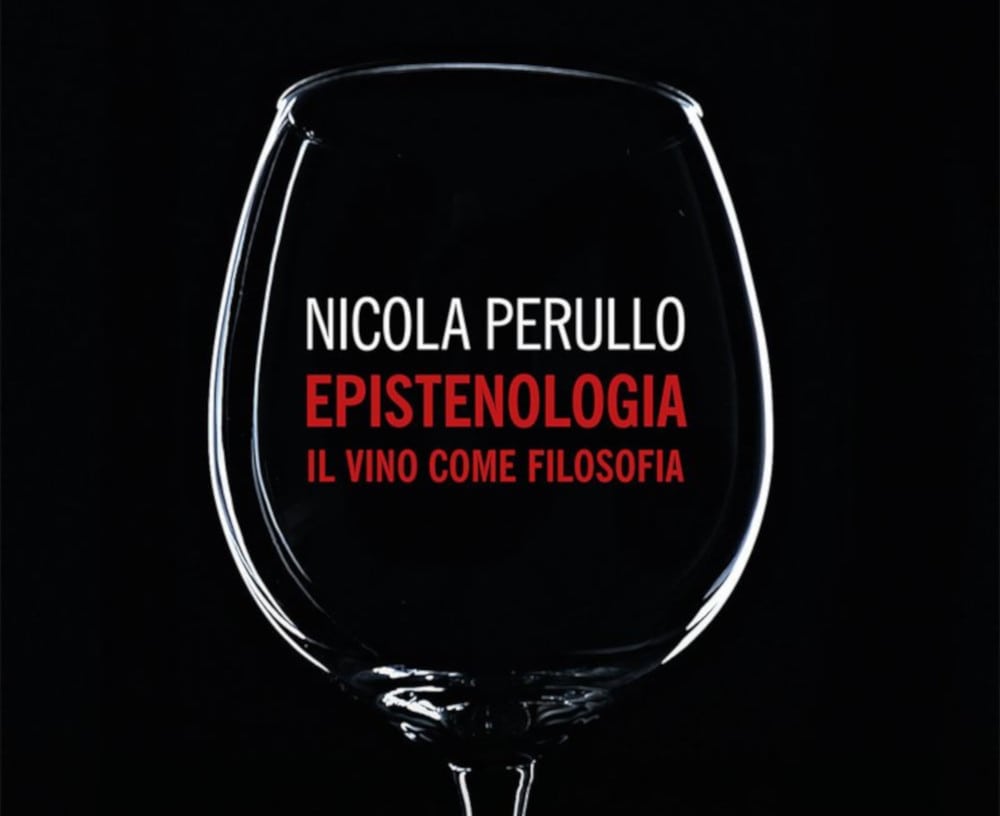Ode all’ebbrezza. Che importanza ha l’alcol nel nostro rapporto con la birra?
Sarò vecchio, resistente al cambiamento, cocciuto come un mulo, ma non posso che sollevare un sopracciglio quando sento parlare di prodotti analcolici, del boom dei fermentati di bassissima gradazione, di quanto questi per una fetta giovane e healthy-savvy della popolazione mondiale rappresentino un segmento in rapida crescita del mercato birrario craft.
Chi mi conosce, conosce anche quel sopracciglio: quando si inarca vuol dire tre cose, perplessità, sdegno, attacco di sarcasmo imminente. E quando sento parlare di alcohol-free come futuro irrinunciabile della birra artigianale l’arcata sull’orbita si increspa perché, per me, questi prodotti non hanno nulla a che vedere col craft; o con la birra in assoluto.
No Alchol? no, grazie
Ok, saranno dei fermentati d’orzo, avranno dentro magari del luppolo e forse in quantità ingenti, sembreranno NEIPA o Pale Ale anche ben fatte ma no, non fanno parte del nostro mondo: semmai ne sono un simulacro, una parodia, e ne riprendono in parte la forma, ma per niente la sostanza: come quelle gomme da masticare a forma di sigarette che andavano tanto nei primi anni Novanta erano una pallida, ridicola, tenera imitazione dei marlboroni dei nostri vecchi.
Ora, prima che qualcuno mi risponda – anche solo in mente sua – che nel 2022 bisogni pensare anche alla salubrità dei modelli di consumo e a regolare le sostanze nocive che, per quanto legali in gran parte del mondo come l’alcol, possono causare problemi di salute; lasciatemi mettere subito in chiaro la mia posizione al riguardo: per citare la scritta che campeggia su una storica t-shirt di un altrettanto storico publican romano, di questo argomento “nun me ne frega un c@Z*0, fidate”.
Rispetto e apprezzo per la loro integrità e forza morale, nonché per lo strenuo attaccamento al benessere fisico e la chiara percezione che questo sia in assoluto più essenziale per la soddisfazione di vivere delle sirene dell’edonismo, gli astemi, i non fumatori, gli sportivi accaniti, coloro che non si sono mai drogati e (parzialmente) anche i vegani: ciò non vuol dire che starò a guardare mentre una qualsiasi di queste scelte salutari individuali viene calata sulla società come unica alternativa possibile, diventando da libera opzione un diktat universale e canonizzato.
Non potete obbligarmi a stare bene per forza! Non avete l’autorità per imporre a nessuno la prospettiva che la salute fisica sia tout-court più importante del vizio e del piacere. E c’è un piacere nell’ebbrezza, nell’alterazione, nello stravizio che per alcune persone è sostanziale al raggiungimento della felicità, e per alcuni prodotti – tra i quali appunto quelli nativamente a base d’alcol – è integrale alla loro stessa natura, e funzionale ad ottenerne un pieno godimento.
Bere, godere.
Citerò, a questo proposito, una delle letture in assoluto più formative che io abbia mai fatto sul tema del bere e, in generale, della gastronomia: l’Epistenologia del filosofo gastronomo ed esteta Nicola Perullo.
Nella sua trattazione su come le cose da bere non siano “oggetti” da vivisezionare con l’operazione a cuore aperto della degustazione, ma “soggetti” viventi con cui il bevitore si interrelaziona in un dialogo equipollente, che muta negli esiti a seconda delle circostanze, dei luoghi, del tempo; il Perullo si dilunga a descrivere come il fattore etilico sia una variabile non trascurabile nell’equilibrio di questa relazione: l’alcol modifica la percezione del bevitore, il funzionamento dei suoi sensi, la sua predisposizione d’animo e il modo in cui il cervello associa le idee agli stimoli – e quindi, in ultima analisi, l’esperienza stessa della bevuta, in maniera radicale.
Elogio all’ebbrezza
Ora, io credo profondamente in questa prospettiva: e credo inoltre che ci sia una cultura dell’ebbrezza che va maturata, come fosse un device per l’autocoscienza e la crescita personale. L’ebbrezza, con la sua euforia che abbatte i freni inibitori, con l’imprudenza e l’avventatezza che sa provocare, può metterci a contatto con pericoli impossibili da sperimentare in condizioni di sobrietà, costringerci a conoscere i nostri limiti e ad ascoltare sensazioni corporee che annunciano l’eccesso perché possiamo fermarci prima che sia troppo tardi; persino portarci a conoscere lati della nostra personalità che solitamente teniamo a freno avvinghiati nelle facili briglie della lucidità.
In questo senso, l’alcol e i suoi effetti possono essere un’esperienza rivelatrice e messianica paragonabile a quella di alcuni riti sciamanici dell’America meridionale a base psichedelica, vere e proprie “opportunità di viaggio” che se affrontate con consapevolezza possono consentirci di identificare alcune asperità e criticità del nostro io, e se non proprio di limarle, se non altro di riconoscerle con chiarezza cristallina.
E poi, parliamoci chiaro: cosa sarebbe un festival birrario senza il brilluccichìo bacchico dell’assenza generale di sobrietà? Quale altro fattore, se non l’alcol, potrebbe trasformare un raduno eterogeneo di persone accomunate solo dall’interesse per uno specifico prodotto, quindi una sterile e generica “fiera”, in una sotterranea celebrazione della gioia di vivere e della volontaria e collettiva, graduale, perdita di controllo? Quale spazio di deregolamentazione ci resta per essere liberi di muoverci e gestirci, a parte questo genere di raduni, in una società in cui quasi tutte le opzioni sono ormai state esplorate e cristallizzate in dettami sempre più rigidi?
Come scriveva Baudelaire, “di vino (e birra), di poesia, o di virtù, ma ubriacatevi” – e non lo faceva giusto per provocare, per giocare al maledetto: ma perché aveva già capito che l’avvento del pieno positivismo ottocentesco avrebbe gettato le basi per instaurare un liberalismo borghese totale e solo apparentemente democratico, uno spazio esistenziale strutturato che nella furia di redigere regole per tutti i giochi possibili avrebbe lasciato l’individuo privo di un’area di sgambamento, costretto in un groviglio di costituzioni e di manuali già fissati, improvvisamente orfano della libertà di agire su terre vergini quando si trattava di operare al di fuori di sé (in alcuni casi, anche al di dentro). L’invito di Baudelaire non è un’esortazione all’abuso fine a se stesso, ma un urlo sferzante e disperato che intende mettere in guardia sulla necessità di preservare gli spazi di manovra interiori mentre la realtà si fa via via più soffocante; e sull’urgenza di trovare un appiglio, un’ancora, un escamotage che ci consentano di raggiungere un luogo in fondo all’anima ancora tutto da mappare, che sia soltanto nostro. Un luogo al quale possiamo arrivare soltanto ignorando e sovrascrivendo i vincoli e le convenzioni sociali: operazione complessa da realizzare da soli, se non appunto sulle ali dell’intossicazione.
E non fatemi nemmeno cominciare a parlare della rilevanza gustativa della componente etilica: già non se ne può più di queste IPA a zero plato, della secchezza totale come unica possibile declinazione della bevuta. Immaginatevi se dovessimo arrivare ad esperire la ricchezza di pan di zenzero di una Stille Nacht, la liquorosità madeirizzata di una Thomas Hardy’s, l’esplosività muscolare di pompelmo e pino di una Pliny. Senza una adeguata stampella alcolica adeguata ad avviluppare il palato e la gola, immaginate la vuotezza, la tristezza! Immaginate quanto sarebbe insensato assaggiare una birra se, ad un certo punto, per legge tutto il grado alcolico brassicolo del mondo dovesse essere contenuto entro il cappello dello 0,5. Immaginate quanti stili morirebbero, istantaneamente svuotati del loro senso, della loro storia. A quel punto, tanto varrebbe bere del tè, o della kombucha.
Che è appunto ciò che i fanatici puristi del salutare, i visionari di un futuro tanto superficialmente inclusivo quanto edulcorato artificialmente e scollato dalle pulsioni umane e dalla realtà preesistente, dovrebbero limitarsi a bere; senza pretendere che questa loro mania diventi per regio decreto una coperta da distendere sull’intero mondo brassicolo col fine di occultarne l’anima godereccia, divenuta d’improvviso pruriginosa, censurabile e scandalosa.