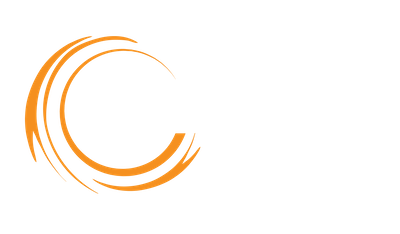Calcolare le IBU ha ancora senso per le IPA?
L’amaro della birra si misura in IBU. La sigla sta per International Bitterness Units, ovvero unità internazionali di amaro. Una scala universale che quantifica la concentrazione di alfa acidi isomerizzati disciolti nella birra. Il valore di 1 IBU corrisponde a una concentrazione di alfa acidi isomerizzati pari a 1 mg/L. La scala va da 0 IBU, caso piuttosto raro per una birra, dove l’amaro in genere è sempre presente, fino ad arrivare potenzialmente ad infinito. Chiaramente ciò non è possibile, per due ragioni principali: la prima, più ovvia, è che oltre un certo valore la concentrazione di alfa acidi isomerizzati satura non potendo fisicamente andare oltre (un po’ come quando si esagera con lo zucchero in una soluzione acquosa); la seconda, meno scontata, è la saturazione del palato. Sebbene la concentrazione di alfa acidi isomerizzati nella birra possa essere tecnicamente portata oltre i 100 IBU (cioè 100 mg/L), ad andare in saturazione a questo punto è il nostro palato. Non riesce a percepire differenze nel livello di amaro quando la concentrazione degli alfa acidi isomerizzati sale oltre una certa soglia. Birre con amaro oltre i 100 IBU sono una trovata di marketing.

Gli alfa acidi, precursori degli alfa acidi isomerizzati, sono composti che si trovano nelle resine del cono di luppolo, nello specifico si tratta del gruppo delle resine morbide, a cui appartengono anche altre sostanze come i beta acidi e gli umulinoni. Questi ultimi sono solubili e amaricanti, ma presenti in concentrazioni trascurabili nel cono di luppolo. O almeno così è stato per diversi secoli di produzione birraria, ma questo lo vedremo nel seguito. Alfa e beta acidi sono amari, ma poco solubili in acqua e in soluzione alcolica. Questo, banalmente, significa che il loro gusto amaro si perde poiché le molecole amaricanti, non essendo polari, non riescono a essere mantenute in soluzione dalle molecole di acqua, che invece hanno una polarità. Per rendere amaricanti le resine del luppolo, nello specifico gli alfa acidi, bisogna riscaldarli. Il calore ne muta la conformazione strutturale, modificando la distribuzione delle cariche elettriche nelle molecole che diventano quindi polari (con carica positiva a un estremo e negativa dall’altro). Questo processo si chiama isomerizzazione. Una volta isomerizzati, gli alfa acidi diventano anche più amari. La bollitura del mosto, tra le altre cose, serve proprio a isomerizzare gli alfa acidi per conferire amaro stabile nel tempo alla birra. I beta acidi invece non isomerizzano con il calore, quindi non contribuiscono all’amaro della birra. Possono diventare solubili se ossidati, ma il processo è lento. Siccome gli alfa acidi, al contrario, se ossidati tendono a perdere potere amaricante, accade che nei luppoli con concentrazioni più alte di beta acidi il potere amaricante si mantenga più stabile nel tempo: l’ossidazione, che agisce sul luppolo durante la conservazione, da una parte riduce il potere amaricante degli alfa acidi mentre aumenta quello dei beta acidi. Questi effetti possono in parte compensarsi. Questa capacità di mantenere il potere amaricante nel tempo viene misurata dall’HSI, ovvero l’Hop Storage Index. Si tratta tuttavia di un fattore trascurabile che raramente viene preso in considerazione dal birraio, anche perché – a meno di casi eccezionali – si tende ad utilizzare luppoli non troppo vecchi.

Calcolare l’amaro
Stimare l’amaro che una certa quantità di luppolo conferisce alla birra non è facile. Sebbene la concentrazione di alfa acidi di ciascun raccolto sia nota grazie a evolute tecniche di misurazione, valutare il tasso di isomerizzazione di queste resine dovuto alla bollitura è piuttosto complicato. La principale difficoltà risiede nelle dinamiche di isomerizzazione: la modifica strutturale degli alfa acidi, dovuta al calore, avviene con dinamiche differenti a seconda del sistema di produzione. Questa variabilità è dovuta a diversi fattori che vanno dalla forma del tino di bollitura, all’intensità della bollitura stessa fino alla concentrazione di zuccheri nel mosto. Con gli anni sono stati elaborati diversi modelli matematici che permettono di produrre una stima degli IBU, tra cui il più utilizzato è quello di Glenn Tinseth, un homebrewer e professore di chimica che elaborò una formula che permette di prevedere gli IBU in base alla quantità dei luppoli utilizzati, al volume di bollitura e agli alfa acidi contenuti nei coni. Il tutto deve essere moltiplicato per il cosiddetto fattore di utilizzazione, un numero che varia a seconda dell’impianto utilizzato e della fase della bollitura in cui vengono aggiunti i luppoli. Viene espresso in unità percentuali. In modo approssimativo, possiamo stimare che il suo valore vari tra 25% per le aggiunte di luppolo a inizio bollitura (ovvero, per una bollitura standard, a 60 minuti dalla fine della bollitura), 10% per aggiunte a 15 minuti dalla fine della bollitura e pochi punti percentuali per aggiunte a 5 minuti dalla fine della bollitura. Questo significa che, anche con aggiunte di luppolo a 60 minuti dalla fine della bollitura, non si riesce a trasferire nella birra più del 25% del potenziale amaricante degli alfa acidi. Allungando la bollitura oltre i 60 minuti si può ottenere qualche punto in più, ma non si riesce ad andare molto oltre perché la curva di estrazione va in saturazione. Da quanto scritto, risulta chiaro come il principale problema di questa formula stia proprio nella quantificazione del fattore di utilizzazione che dovrebbe essere stimato in base al proprio sistema di produzione, oltre che al momento della bollitura in cui viene aggiunto il luppolo. Inevitabilmente, l’utilizzo di un modello matematico basato su dati empirici porta a stime degli IBU che possono essere significativamente sballate. Questo problema è stato ampiamente evidenziato da diversi esperimenti, tra cui uno molto interessante ideato da Drew Beechum e Denny Conn, noti homebrewer americani e conduttori del podcast Experimental Homebrewing. I due hanno ingaggiato una trentina di homebrewer, ascoltatori del loro podcast, chiedendo loro di produrre in casa tre ricette di birre luppolate: una APA, una IPA e una Double IPA. A tutti i partecipanti sono state spedite le stesse varietà di luppolo, provenienti dallo stesso raccolto. Ciascuno ha prodotto le tre birre sul proprio sistema, per poi inviarle a Drew e Denny che a loro volta le hanno inviate in laboratorio per far misurare gli IBU. I risultati sono stati sorprendenti. Nella Double IPA, dalla cui ricetta la formula di Tinseth stimava un amaro da 76 IBU, i valori misurati variavano tra 45 e 71 IBU; nella IPA, teoricamente da 58 IBU, le misure hanno rilevato valori tra 37 e 66 IBU; nella APA, con 32 IBU teorici, abbiamo una variabilità compresa tra 20 e 43 IBU. Ma se le evidenze mostrano una tale variabilità nell’errore dell’applicazione della formula di Tinseth, perché viene ancora utilizzata? Non ne esistono altre più affidabili? Esistono altre formule, come quelle di Rager, Garetz o Noonan. Ciascuna utilizza un approccio differente, ma nessuna riesce a dare valori precisi, utilizzata così com’è. Ogni formula andrebbe adattata al proprio impianto, al formato di luppolo utilizzato (ad esempio coni o pellet), alla concentrazione zuccherina del mosto e ad altri fattori che complicano molto il quadro. A livello casalingo, dove non si porta la birra in laboratorio per misurare la reale concentrazione di alfa acidi isomerizzati, la strada più semplice è quella di scegliere una formula – di solito Tinseth – e utilizzarla per tutte le stime. Poco importa se la formula prevede un amaro di 80 IBU a fronte di un amaro effettivo (se venisse misurato) di 60 IBU. O meglio, questo può crearci problemi con le prime birre prodotte in casa, dove l’amaro potrebbe risultare leggermente sballato (ok, a volte anche significativamente sballato) rispetto alle previsioni, ma già dalla seconda birra potremo aggiustare il tiro. Quando penso all’amaro che desidero ottenere nelle mie IPA, cerco indietro tra le mie cotte precedenti (il cui amaro è stato calcolato sempre con la formula di Tinseth) e prendo la birra che ricordo avere l’amaro che desidero ottenere. A questo punto replico il valore delle IBU nella nuova ricetta e via. Poco importa se l’amaro effettivo coincide con il valore stimato: a parità di densità del mosto e del sistema utilizzato, la replicabilità della sensazione amaricante è garantita. A meno, ovviamente, di piccole variabilità che sono tuttavia trascurabili. Abbiamo quindi risolto il problema? Purtroppo, no. O meglio, solo in parte.
Il dry hopping altera le IBU?
Si è sempre detto che le aggiunte di luppolo dopo la fermentazione in dry hopping non alterano l’amaro della birra, ma questa concezione è stata totalmente rivista a valle delle ultime evidenze scientifiche. Le resine morbide dei luppoli, alfa e beta acidi, pur essendo amare, non sono solubili nel mosto e nella birra e quindi non sono in grado di rendere amara la birra se aggiunte a freddo. Come già detto, la bollitura isomerizza gli alfa acidi – non i beta acidi – rendendoli più amari e solubili. Questo è vero per la maggior parte delle birre, quantomeno finché le quantità di luppolo utilizzate per il dry hopping non iniziano a diventare significative. Se fino a una decina di anni fa le quantità di luppolo impiegate in dry hopping – anche per le IPA – non andavano mediamente oltre i 6-7 g/L, oggi questi valori vengono ampiamente superati. Inoltre, con l’avvento delle New England IPA, la torbidità, in questo caso ricercata, riesce a mantenere in sospensione composti che altrimenti avrebbero una scarsissima solubilità nella birra. Se i dosaggi sono bassi, questi fenomeni sono ininfluenti, ma quando si impiegano grandi quantità di luppolo, le dinamiche possono cambiare significativamente, rendendo di fatto superate le logiche di calcolo e misura degli IBU a cui per anni siamo stati abituati. Vediamo in che termini.
Oltre ad alfa e beta acidi, nei luppoli troviamo anche altri composti in grado di conferire amaro alla birra. Tra questi, i più interessanti per i nostri ragionamenti sono gli umulinoni. Si tratta di resine morbide che derivano dall’ossidazione degli alfa acidi. Sono altamente solubili nel mosto e nella birra e hanno una resa amaricante pari a circa il 66% degli alfa acidi isomerizzati. Si formano in genere durante la crescita del cono ma anche nel corso dei processi di lavorazione, in particolare la pellettizzazione. La loro concentrazione media è piuttosto bassa, parliamo di meno di un punto percentuale rispetto a concentrazioni di alfa acidi che variano tra il 2% e il 20%. Quindi, mediamente, il contributo amaricante che gli umulinoni possono conferire alla birra è trascurabile. Quando però le dosi di dry hopping aumentano significativamente, la quantità di umulinoni che si solubilizza nella birra, anche a freddo (non hanno bisogno di isomerizzare per diventare solubili) diventa significativa. Ecco, quindi, che il dry hopping può contribuire all’amaro, aumentandolo di diverse IBU nel caso di birre estremamente luppolate a freddo. E questo è un primo elemento, ma non l’unico.
Gli alfa acidi non isomerizzati, che invece sono presenti in quantità significative nel luppolo, possono rimanere in sospensione se la birra presenta una decisa torbidità. Questo accade perché le resine vengono mantenute in sospensione da proteine e polifenoli, introdotti in grandi quantità dal birraio quando si ha l’obiettivo di produrre una birra volutamente opalescente. Nella forma non isomerizzata, tuttavia, gli alfa acidi mantengono il loro modestissimo potere amaricante, pari in questo caso a circa il 10% rispetto alla loro controparte isomerizzata. Anche in questo caso, è chiaro che se il dry hopping è contenuto, anche l’aumento dell’amaro dovuto alla solubilizzazione degli alfa acidi è trascurabile. Ma se il dry hopping aumenta e la torbidità è significativa, gli alfa acidi non isomerizzati possono dare un contributo all’amaro. Ma la questione, incredibilmente, è ancora più complicata di così.

Diversi esperimenti hanno infatti rilevato che, in alcuni casi, gli alfa acidi non isomerizzati, quando entrano in soluzione durante il dry hopping, possono andare a sostituirsi a quelli isomerizzati, riducendo di fatto l’amaro della birra. È stato verificato che in birre con un amaro che va dai circa 30 IBU in su, nel caso di dry hopping pesanti, gli alfa acidi non isomerizzati vanno a sostituire – in parte – quelli isomerizzati. Questa dinamica è più marcata man mano che le dosi di dry hopping aumentano. Un alfa acido non isomerizzato che si sostituisce a un alfa acido isomerizzato riduce l’amaro di circa 0.9 IBU, avendo gli alfa acidi non isomerizzati un potenziale amaricante pari al 10% di quello dei corrispettivi isomerizzati. Ecco, quindi, che la birra addirittura perde una parte dell’amaro con il dry hopping. Se invece la birra parte da un amaro minore di 30 IBU prima del dry hopping, questa sostituzione non avviene, anzi: entrano in soluzione, al fianco degli alfa acidi isomerizzati durante la bollitura, una quota di alfa acidi non isomerizzati e gli umulinoni di cui abbiamo parlato prima. In questo caso, il dry hopping fa aumentare l’amaro. Queste dinamiche, verificate sperimentalmente, sono difficilmente prevedibili. Non abbiamo ancora delle formule matematiche che ci possano aiutare a prevedere l’amaro finale che otterremo, in termini di IBU, in una birra torbida con pesante luppolatura in dry hopping. Si va ancora a braccio, basandosi sulla propria esperienza o su quella di altri homebrewer o birrifici.
Anche gli strumenti possono sbagliare
Ma c’è ancora di più: anche misurando gli IBU a posteriori si commettono degli errori di misura, spesso piuttosto grossolani. Questo accade perché il metodo classico di misura degli IBU si basa sull’assunto che a contribuire all’amaro siano solo gli alfa acidi isomerizzati (come è nella maggior parte dei casi, ovvero in birre non pesantemente luppolate in dry hopping). Con gli anni è stata quindi affinata una tecnica che misura la concentrazione degli alfa acidi isomerizzati nella birra in base alla misura di una determinata lunghezza d’onda che viene assorbita da queste molecole. In base all’assorbimento, si valuta la concentrazione degli alfa acidi isomerizzati e quindi le IBU. 1 g/L di alfa acidi isomerizzati corrisponde a 1 IBU. Semplice. Il problema è che la stessa lunghezza d’onda viene assorbita anche da altre resine morbide, tra cui gli alfa acidi non isomerizzati e gli umulinoni. Se questo errore è piccolo nelle birre standard, scambiare un alfa acido isomerizzato per uno non isomerizzato può in altri casi portare a sovrastimare di parecchio la misura l’amaro. In una New England IPA, ad esempio, la misura dell’amaro condotta con il metodo classico può portare a errori di sovrastima fino a diverse decine di IBU.

Conclusioni
Gli errori di misurazione appena visti, insieme a quelli di calcolo dovuti a formule vecchie che non prendono in considerazione l’alterazione delle IBU con il dry hopping, traccia un quadro davvero complicato per birrai e homebrewer. Sempre di più occorre affidarsi all’assaggio per valutare l’effettivo contributo del luppolo all’amaro della birra, staccandosi da rigide formule che al giorno d’oggi trovano scarsa applicazione in stili che hanno fatto della luppolatura spinta il proprio tratto distintivo. Come sempre quando si produce birra, bisogna mantenere una mente aperta e un palato allenato. La scienza arriverà in nostro aiuto, ma per il momento si naviga a vista.