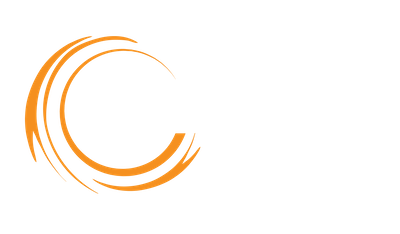Universo IPA: tutti gli stili della categoria americana più amata e replicata
Nel mondo della birra lo sappiamo, gli stili riflettono protocolli di lavorazione che hanno un carattere consuetudinario, non fissati da un documento con valore di legge e perciò destinati a poter modificarsi nel tempo, a volte anche in maniera repentina. Un esempio di tutto ciò? La costellazione delle American IPA e delle loro innumerevoli derivazioni. Ecco, è proprio su questo panorama che ci soffermiamo oggi, puntando il binocolo, in particolare, su due gruppi di identità tipologiche in merito alle quali si ha l’impressione che esistano punti di opacità, di reciproca sovrapposizione e di possibile confusione. Il primo gruppo include le American IPA, le West Coast IPA, le Modern IPA e le New England IPA; il secondo gruppo coincide con la coppia formata da Session IPA e Micro IPA. Per condurre l’indagine ci siamo rivolti direttamente ad alcuni tra i birrai più apprezzati per il rispettivo lavoro in questo specifico ambito, quello dei luppoli: Marco Valeriani (Alder), Marco Ruffa (Crak), Luca Tassinati (Liquida), Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani (MC 77), Giovanni Faenza (Ritual Lab).

AMERICAN IPA
È la definizione che, in principio, ha segnato ufficialmente il punto di divergenza tra le India Pale Ale storiche, ovvero le britanniche (oggi puntualizzate nella loro identità con la dicitura English IPA), e ciò che è venuto dopo, da metà anni Settanta in sù, sostituendo i luppoli tradizionali targati UK con quelli moderni: il Cascade e i suoi discendenti. Un universo troppo vasto per non generare designazioni specifiche, rispetto alle quali la classificazione di American IPA, attualmente, come una sorta di contenitore generale, abbraccia tutte le produzioni legate dal denominatore comune, e inderogabile, rappresentato dalla supremazia dei luppoli nuovomondisti, ma al contempo prive di connotati puntualmente corrispondenti a una delle varie caselle stilistiche più specifiche (New England, Modern, West Coast e così via). “Quella di American IPA – dice Valeriani – è una denominazione omnicomprensiva. Alla quale, sul piano della genealogia, fanno capo le altre tre definizioni di cui si sta parlando (West Coast, Modern, NEIPA), che ne sono sottocategorie”. In virtù di tale status, prosegue, “oggi il contenuto dell’espressione American IPA è plasmato un po’ a piacimento; la sua duttilità è utile a etichettare birre che non corrispondano precisamente appunto a una delle sue sottocategorie, magari perché assemblano elementi peculiari dell’una o dell’altra: ad esempio la nostra Rockfield è una West Coast, ma con lieviti (di origine inglese) più morbidi, più esterificanti, tipici di una Modern o di una NEIPA”. E se tale utilizzo disinvolto della locuzione American IPA può sollevare obiezioni, “allora – aggiunge – l’alternativa è alimentare la deriva schizofrenica dei sottostili. Per dirne una: birre che, nei livelli d’amaro e di spessore palatale, si collochino a metà tra West Coast e New England, c’è chi le battezza come Mountain IPA”. Sulla nozione di American IPA come classificazione-madre, concorda anche Giovanni Faenza. Che aggiunge un’osservazione interessante: “In termini di connotati organolettici” dichiara, “fino a qualche anno, fa presentava diversi punti di sostanziale coincidenza con le West Coast IPA. Poi, però, con l’emersione e il consolidamento delle odierne sottocategorie (NEIPA, Modern, la stessa West Coast), la qualifica di American IPA ha acquisito la condizione di una categoria più larga in termini di ampiezza e meno definita in termini di specificità”. Sulla stessa lunghezza d’onda Luca Tassinati: “Nello stabilire i punti che distinguono questa definizione da quelle di New England, West Coast e Modern IPA, ritengo sensato assumere alcuni parametri di riferimento: il colore, la pulizia, il corpo (ovvero la pienezza), l’amaro e la bevibilità”. Ecco, in questo senso, l’American IPA, “si configura non tanto come una categoria di classificazione posizionata sullo stesso livello delle altre, ma piuttosto una macrocategoria; nel cui perimetro si possono far rientrare, genericamente, diverse tipologie specifiche, quantomeno quelle di West Coast IPA e Modern IPA, le peculiarità non sono tali da renderne il profilo così puntualmente fissato, cosa che invece può affermarsi per le NEIPA”. Sullo specifico cordone ombelicale American IPA-West Coast IPA e sulle sue modificazioni nel tempo, battono anche Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani: “Storicamente è dalle American IPA che discendono le altre tre tipologie di cui stiamo parlando. E visto che, sempre storicamente, le American IPA in quanto tali sono nate sulla West Coast, c’è anzitutto da chiedersi cosa, oggi, le distingua appunto dalle dalle West Coast IPA; le quali, come categoria a sé stante, sono state ufficialmente introdotte nelle linee guida del Great American Beer Festival con il 2023 (il che peraltro indica come, fino a quel punto, non si fosse avvertita l’esigenza di codificare una differenziazione)”. Ebbene, rispetto a una West Coast IPA odierna, “il bagaglio di un’American IPA, a nostro avviso, contiene malti caramel o crystal; ha quindi una punta di colore in più; ha più corpo e più dolcezza: il che implica la possibilità di spingere su un amaro più evidente, senza renderla sbilanciata. Inoltre, questo tipo di base maltata si sposa alla grande con luppoli classici, agrumati e resinosi, un po ‘meno con varietà moderne, dalla timbrica fruttato-tropicale”. Ecco allora che, in questa luce, le American IPA comunque riguadagnano o, forse meglio, mantengono, uno spazio di distinguibilità: aspetto pulito o di leggera velatura; fondamenta maltate più solide e un conseguente rapporto di forze con l’amaro meno spostato a favore di quest’ultimo. Su questa piattaforma di tratti somatici, pur a maglie larghe, chiosa Marco Ruffa: “L’American IPA è la matrice di tutti gli stili, la tipologia che, come minimo, stabilisce e trasferisce alle altre il comune denominatore fondamentale, ovvero il ruolo predominante del luppolo. Poi, ovviamente, pur essendo abbastanza oggettivo il fatto che si sta andando verso un quadro di confini organolettici sempre meno definiti fra stile e stile, l’American IPA in quanto tale presenta alcuni connotati distintivi: base maltata di una certa importanza, bilanciante; amaro posizionato su un livello moderato, che evidenzia appunto la qualità dei luppoli americani, ma senza esagerare”.
AMERICAN IPA
- La madre delle IPA moderne
- Etichetta omnicomprensiva
- Nel senso più stretto individua versioni più old style: profilo maltato più carico e amaro ben definito

NEW ENGLAND IPA
Sua mondanità, la NEIPA. Adorata da molti, tollerata con insofferenza da altri, poco importa. Tra le regine dei rotocalchi birrari, un posto al sole le spetta di diritto. E la colpa o il merito è proprio delle sue fattezze così ben incise e sfacciate: aspetto brumoso, corpo palpabile, amaro al minimo sindacale, aroma deflagrante che spinge soprattutto sulla frutta tropicale. “Senza dubbio – rimarca Valeriani – nel caso delle NEIPA ci sono elementi ben identificativi. Primo, una spinta nasale importante, affidata a luppoli (Mosaic, Galaxy, Citra…) dal timbro fortemente fruttato, al quale contribuiscono anche lieviti di origine inglese più inclini a esterificare, lavorando sui luppoli stessi in biotrasformazione. Secondo punto, un livello di amaro più basso possibile, quindi poco luppolo in caldaia e vagonate in dry hopping. Terzo requisito, un aspetto decisamente velato, in virtù anche dei lieviti appena menzionati, ma soprattutto di miscele che includono ingredienti proteici, opacizzanti, come fiocchi d’orzo o avena, che incrementano il corpo. E per non farsi mancare niente in questo senso, talvolta spuntano anche maltodestrine e lattosio. La nebbiosità di queste birre, in alcuni casi raggiunge livelli tali per cui è giustificata la locuzione di Hazy IPA, se non addirittura di Murky IPA (letteralmente, torbida). Termini che tra l’altro, colgono l’obiettivo di evitare il riferimento geografico al New England”. Caratterizzarsi fino all’estremizzazione sembrerebbe insomma la ragion d’essere delle NEIPA. “Tra quelle di cui stiamo parlando”, conferma Faenza, “è una classificazione a sé stante, non si discute: contrassegnata da un serie di connotati organolettici precisi. Velatura densa, rotondità importante, aroma da luppoli esplosivo, prescindendo dalla loro provenienza: conta che la birra sia una sorta di succo alla frutta, da cui anche gli attributi di Hazy Ipa o Juicy IPA”. Una prerogativa, questa della carnosità palatale, sottolineata anche da Ruffa: “Il biglietto da visita è inequivocabile: un aspetto densamente velato (in certi casi rimarcato come hazy); poi un identikit completato da un aroma intenso (di timbro molto molto fruttato, con note tropicali); e per contro da un grado di amaro molto basso, che s’incastona in una bevuta morbida e succosa”. Talmente tanto succose da pagare dazio in termini di bevibilità. È ciò che sostiene Tassinati: “Nel caso delle NEIPA, la fisionomia è stabilita con precisione, scolpita con chiarezza, rispetto a tutti i parametri che a mio parere sono da assumere come discriminanti. Primo, la pulizia, alla quale qui si rinuncia. Secondo punto, il corpo: che risulta pieno, quasi masticabile. Terzo, il colore: chiaro o al massimo dorato, frutto di una scelta di malti finalizzata a lasciare il massimo spazio all’espressione aromatica dei luppoli in tutta la loro freschezza ed esplosività. Quarto punto, l’amaro: il cui livello (se la birra è ben fatta) si rivela pressoché assente o, comunque, molto moderato. Tutto ciò, peraltro rende le NEIPA a mio avviso meno bevibili rispetto a IPA più pulite e filanti nella sorsata”. Su un diverso tasto del paradigma-NEIPA calcano invece la loro attenzione Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani, ovvero il sacrificio della base maltata (tanto da scaricarne il colore fino a tonalità pergamena), sull’altare costituito dall’egemonia del luppolo. “Le NEIPA – questo il loro pensiero – sono una derivazione delle American IPA; quindi il prodotto di una linea evolutiva che, nel nostro caso, ha seguito alcune direttrici nitide. Tra esse, la ricerca di una torbidità stabile (e quindi ben fatta) che in queste birre non è mai dovuta a lieviti poco flocculanti. Si tratta sempre di complessi proteina-polofenoli, nei quali i polifenoli vengono dal luppolo e le proteine possono venire o dal grain bill e/o dal rilascio da parte di specifici ceppi di lieviti di glicoproteine (il famoso gene hzy1). Più che lieviti poco flocculanti è corretto parlare quindi di lieviti che favoriscono la torbidità. Altra caratteristica è l’inclinazione verso una compagine aromatica caratterizzata dallo stesso lievito, con ceppi non neutri, ma dotati di una certa capacità di generare aromi, che ben si sposano con le note fruttato-tropicali dei luppoli più moderni. Infine, la preminenza proprio del luppolo, che porta a sacrificare l’espressione della base maltata, così da non interferire in alcun modo con il ruolo dei coni: molte NEIPA di ultima generazione sono di un paglierino tendente quasi al bianco; e ciò grazie anche all’impiego di ingredienti fermentabili come lo zucchero brewers crystal o come il frumento crudo in formato torrified wheat”.
NEIPA
- Intensi profumi tropicali
- Corpo elevato
- Torbidità
- Amaro minimo
- Lieviti caratterizzanti

WEST COAST IPA
Altro identikit impresso con solidità; per una fisionomia che è diametralmente in opposizione a quella di una New England. Così la riassume Marco Ruffa: “La West Coast sfoggia un aspetto limpido e sguaina, al sorseggio, un amaro ficcante, volutamente tagliente, accentuato da controcanti maltati molto sottili e incamminato lungo una curva il cui picco svetta nel finale di bevuta secco, apice di una condotta gustativa che richiama tematiche resinose e agrumate”. Argomenti ripresi e avvalorati, nel suo approccio metodico, da Luca Tassinati: “Rispetto ai parametri-chiave le West Coast si collocano in posizione quasi antitetica rispetto alle NEIPA. La loro immagine è decisamente limpida e brillante, e il loro colore è tutt’al più dorato, escludendo dalla ricetta malti che potrebbero interferire con gli argomenti olfattivi del luppolo. La loro corporatura, poi (almeno nell’interpretazione che ne diamo noi a Liquida), dev’essere presente nei termini in cui serve a fornire la struttura in grado di sostenere sia l’aroma sia l’amaro del luppolo: un telaio che ha il compito reggere, ma senza ricorrere alla consistenza di malti cara o crystal”. C’è poi il ruolo dell’amaro da luppolo: “Che si fa sentire – aggiunge Luca – in misura incisiva, sempre peraltro in armonia con la loro espressione aromatica. Infine, la loro bevibilità deve, o almeno dovrebbe, essere… senza limiti”. Considerazioni pregnanti, dalle cui pieghe, tra l’altro, affiora quella che si pone come una specifica chiave di lettura, nella nozione delle West Coast odierne: l’eliminazione di comprimari olfattivi (siano essi malti o lieviti) che possano fare concorrenza alla cristallinità dell’espressione aromatica del luppolo. Lo sottolineano a loro volta, con dovizia di particolari, sia Marco Valeriani sia la coppia Scisciani-Pomposini. “Come detto parlando di American IPA”, spiegano i signori MC77, “le West Coast IPA ne rappresentano una derivazione: uno dei punti di approdo della loro parabola evolutiva. In quali direzioni? Anzitutto l’abbandono dei malti caramel o crystal. I quali (vero e proprio anello di congiunzione tra American IPA e English IPA), con il passare degli anni sono diventati meno desiderabili nelle versioni a stelle e strisce. I produttori, preferendo malti a bassa colorazione, li hanno via via ridotti nel dosaggio, se non addirittura esclusi dalla ricetta. Questo si traduce in fondamenta maltate più secche, quindi, ricorso al PIls come malto base, e a temperature di conversione più basse in ammostamento. D’altra parte il gusto è cambiato secondo direzioni (su tutte quella che premia la freschezza dei profumi e la nettezza di quelli luppolati), rispetto alle quali questo spostamento nella composizione dei malti è stato una conseguenza. In primis, perché la grande delicatezza dei crystal li rende molto propensi all’ossidazione, determinando un invecchiamento precoce della birra finita, e questo è un comportamento assolutamente inadatto a una tipologia che ha il suo punto di forza proprio nella freschezza. Inoltre, le note olfattive prevalentemente fruttato-tropicali dei luppoli più contemporanei trovano maggior esaltazione quando poggiano su una base maltata priva di caramellature”. Ed è questo il punto di caduta verso le odierne West Coast IPA: “Che sono chiare, secche, dotate – dicono ancora Cecilia e Matteo – di una luppolatura più attuale e cosmopolita rispetto al profilo di un’American IPA. E che, al palato, sono provviste di un amaro comunque distinguibile nel paragone con una NEIPA, sebbene, prendendo invece come termine di un’American IPA, offrano minore possibilità di recedere sul luppolo in caldaia, avendo abbandonato, nel tempo, i malti caramellati e il loro ruolo bilanciante”. In linea la considerazione di Valeriani: “L’identikit West Coast è scandito da punti ben identificanti. Un amaro netto, evidenziato da una secchezza decisa, molto pulita. La quale è merito anche di lieviti ben attenuanti, ben flocculanti, che contribuiscono a consegnare un aspetto limpido. Il corpo è scorrevole, filante. E poi l’aroma: potente nell’intensità e affidato alle migliori varietà di luppolo disponibili (da USA, Nuova Zelanda o altro ancora), oggi utilizzate sia in pellet sia anche in forma di concentrati (Cryo, CGX, HyperBoost, Subzero, Spectrum). E il profilo olfattivo di questi luppoli brilla senza concorrenza di altri contributi, perché i lieviti di cui parliamo sono poco o niente esterificanti. In tal senso – sempre parlando di moltiplicazione delle classificazioni – in giro troviamo anche la definizione di California IPA; e quando il mix dei luppoli in questione prevede tipologie (Columbus, Simcoe, Amarillo) orientate a conferire sensazioni da marijiuana fresca, ecco che sbucano le Dank IPA”. Certo, il tema del luppolo implica quello delle sue cultivar; e a focalizzare l’argomento, nel contesto delle West Coast IPA, è anche Giovanni Faenza: “Sebbene l’aggettivazione West Coast nasca chiaramente come riferimento a un’origine che è legata alla costa occidentale degli Usa, oggi diverse interpretazioni includono varietà magari prevalentemente statunitensi, ma non solo: aprendo le porte ad esempio a tipologie dell’intera area pacifica, come il Galaxy (australiano) o il Nelson Sauvin (neozelandese)”.
WEST COAST IPA
- Limpida
- Profumi resinosi-agrumati
- Amaro deciso
- Corpo esile
- Malto e lievito neutri

MODERN IPA
Minore nettezza emerge nel tratteggio fisionomico delle Modern IPA. Il che non significa equivocità di temperamento, quantomeno perché la loro personalità si colloca tra due termini di riferimento, rispetto al quali getta quasi un ponte: da un lato le NEIPA, con le loro dense sospensioni, il loro corpo tangibile e il loro amaro ai minimi termini, e dall’altro le West Coast IPA, con la loro limpidezza, la loro secchezza di bevuta, la loro nervatura amara affilata e vigorosa. E a fare da tessuto connettivo fra tutte le tre classificazioni, il comune denominatore di una spinta olfattiva trascinante. In questa triangolazione la Modern si muove tra le linee, con un contegno meno ingessato rispetto alla fissità di NEIPA e West Coast, permettendosi di oscillare tra quei due poli. “Dal mio punto di vista – spiega Faenza – per criteri di vicinanza concettuale, scatta un confronto inevitabile con le NEIPA. Rispetto alla quali, pur ricalcandone la prorompenza aromatica, la Modern IPA può tuttavia essere anche limpida o, almeno, velata ma solo leggermente, non certo torbida. Specularmente, siamo altresì distanti da una West Coast o da un’American IPA per l’intensità e la qualità dell’amaro: il quale, nelle seconde, è più netto e affilato; mentre nel nostro caso è inferiore, in termini di livello, e più morbido. Estremizzando il concetto; se una Modern IPA la bevo a occhi chiusi (quindi perdendo l’informazione relativa al grado di opacità), avverto profumi alle stelle e un amaro rotondo ed elegante, non pungente né astringente: alla fine un profilo simile a una NEIPA”. Incline a rilevare un’affinità elettiva tra New England e Modern IPA è anche Valeriani, ma in modo più sfumato. “Con le NEIPA c’è un punto di contatto preciso: l’utilizzo di lieviti non molto flocculanti e capaci di una certa esterificazione lavorando anche sulle biotrasformazioni. Il che determina un complesso di sensazioni palatali più orientato alla morbidezza, rispetto a quelle delle West Coast; ma, per contro, non certo allineato alla pastosità delle NEIPA. Né alla loro densa nebbiosità: con le Modern IPA siamo sui livelli di una sottile velatura; non a caso, di solito almeno, si evita o si minimizza l’impiego di ingredienti opacizzanti (che ispessirebbero la corporatura)”. Più baricentrico invece, tra New England e West Coast, il posizionamento della Modern secondo Ruffa e Tassinati. “Vedo la Modern – esordisce il birraio di Liquida – come il possibile anello di congiunzione tra New England e West Coast IPA. Il colore è chiaro, per lo stesso motivo evidenziato in ordine a quelle due tipologie: lasciar parlare il luppolo; che, qui, fa la voce grossa, come quella di una NEIPA. In relazione all’aspetto, di norma ci si trova di fronte a birre pulite o, al massimo, leggermente velate. L’amaro strizza invece l’occhio più alle NEIPA, rivelandosi tendenzialmente morbido o comunque poco presente e persistente. Quanto al corpo, risulta al contrario più leggero, più agile: più vicino, di nuovo, a una West Coast. Il che determina una bevibilità essa stessa simile a quella delle West Coast, pur con qualche limite dovuto a una condotta gustativa che, come appena detto, si sbilancia sul versante della dolcezza”. Parole a cui fanno eco quelle di Marco Ruffa. “La Modern IPA – dice – è la tipologia più variabile per livello di velatura; e in termini di temperamento organolettico complessivo, quella che rappresenta quasi un’area di transizione tra la West Coast e la NEIPA. Ne combina infatti le caratteristiche fruttate e luppolate; bilanciando l’amaro con un tocco di innovazione rispetto agli stili tradizionali e utilizzando luppoli cosiddetti moderni: cioè le varietà di luppolo più chiacchierate quando si tratta di fare la selezione, cultivar quali Mosaic, Idaho 7, Citra, Nelson Sauvin, Strata e altre ancora”. Tenta una chiosa il duo Pomposini-Scisciani che precisa: “Per quanto riguarda le Modern IPA ci alleniamo al pensiero della maggioranza anche se con il sospetto che siano NEIPA fatte senza consapevolezza. Quindi una IPA prodotta con tecniche di luppolatura moderne, in cui il luppolo è utilizzato prevalentemente nella fase fredda ed in whirlpool; dove il grain bill lascia spazio alla luppolatura; con un amaro posizionato tra una West Coast e una Neipa; e aspetto tendenzialmente limpido o leggermente velato”.
MODERN IPA
- Velata ma non torbida
- Amaro dosato ma presente
- Mix di note tropicali, resinose, agrumate
- Corpo medio
- Lieviti caratterizzanti

SESSION IPA e MICRO IPA
Sostanzialmente univoco l’inquadramento del rapporto tra Session IPA e Micro IPA: in termini stringati, la sostanza è la seguente. Premesso che si parla di una variante dell’archetipo-American IPA, quella delle Session IPA è una categoria bene o male definita, se non altro perché il suo perimetro vitale si colloca non oltre i 5 gradi. Se poi l’asticella scende sotto i 4, ecco che fa capolino l’esigenza di ricorrere a una distinzione ulteriore. Un’esigenza, tuttavia, dettata più da ragioni commerciali che non di effettiva opportunità tassonomica. “Tra Session IPA e Micro IPA – affermano Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani – avvertiamo una differenza che sentiamo legata esclusivamente all’alcolicità. Le prime arrivano al 5% (distinguendosi dalle Pale Ale per una minore quantità di luppolo e dalle American IPA per la struttura più esile); mentre le seconde scendono a taglie etiliche bassissime”. In sintonia con queste, le parole di Giovanni Faenza. “La Session IPA è una tipologia definita, mentre la Micro IPA è un suo sottostile concepito a sentimento: la prima si caratterizza per una taglia alcolica che non supera il 5%; la seconda se ne distingue perché, nel suo caso, la gradazione può scendere a livelli, fino tra il 2.5 e il 3%, che, nella percezione corrente, sono avvertiti come talmente bassi da risultare anomali anche per una Session. È possibile che, magari pure non volontariamente, l’aver inventato la formula MIcro IPA sia servito a offrire un passaggio d’ingresso sul mercato per prodotti a basso o nullo grado alcolico: tanto è vero che, quando ne sono comparsi i primi esemplari, l’accoglienza è stata, quasi, nei termini di una blasfemia, di fronte appunto alla loro gradazione così ridotta. Si tratta comunque di una distinzione sottile: di tipo mi vien da dire tecnico, il cui contenuto è compreso più che altro da noi produttori: anche perché, non è facile sfornare una Micro IPA che non sia un’acqua luppolata, amara e astringente”. Un tasto, quello della difficoltà esecutiva, su cui insiste anche Luca Tassinati: “Premesso, anche per Session IPA e Micro IPA, l’inderogabile precetto di un colore chiaro (la priorità è sempre quella: far risaltare gli aromi del luppolo), se dovessi definire una Session IPA, direi che, nel suo perimetro, rientrano tutte le luppolate di stampo americano, non hazy e con un tasso alcolico tra il 4 e il 5%. In pratica, un’American IPA a bassa gradazione: aspetto pulito, corpo presente ma non pesante, luppolatura importante in aroma e amaro. Quanto alla Micro IPA, direi che, rispetto a una Session IPA, si posiziona su registri ancora più bassi in termini di taglia etilica e di corporatura; ma su valori dimensionali, al contrario, paragonabili, in ordine all’intensità dei profumi e dell’amaro”. Infine, l’idea di una spinta legata prioritariamente al marketing come fattore determinante nella genesi della definizione Micro IPA è sostenuta con energia da parte di Marco Valeriani. “Partiamo – dice – dalle Session IPA e dal loro discrimine alcolico: ovvero la soglia del 5%. Al di sotto, secondo me, potrebbe tranquillamente non esserci altro, come definizioni, se non le Table. Mi viene in mente un esempio immediato: la Table Beer di Kernel. Poi, d’altra parte, intervengono le ragioni commerciali; perché un prodotto del genere, se lo battezzi come Micro IPA, con ogni probabilità lo vendi meglio: il magnetismo di quella sigla, IPA, è irresistibile. Però, ripeto, a mio avviso si tratta di una piega solo commerciale”.