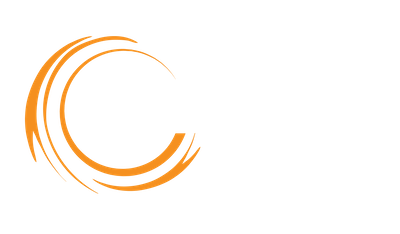Generazione Zero Alcol: cosa bevono i giovani?
È un dato di fatto supportato da statistiche e ricerche di ogni sorta: la Gen Z beve meno alcol rispetto alla generazione precedente, quella dei Millennial, che a sua volta registra consumi inferiori rispetto alla progenitrice Gen X. In particolare, secondo gli studi di Gallup (nella ricerca “Young Adults in U.S. Drinking Less Than in Prior Decades”), i sondaggi di auto-analisi somministrati a un campione demografico trasversale hanno riportato per la fascia di popolazione tra i 18 e i 34 anni un decremento percentuale di 10 punti sulle tre metriche “mi capita di bere bevande alcoliche”, “ho bevuto alcol nel corso della scorsa settimana” e “a volte bevo più di quanto dovrei”. È da notare inoltre che la ricerca sia stata condotta lungo l’arco di due decadi, esaminando periodi di tre anni per una maggiore rappresentatività del campione (esattamente nei trienni 2001-2003, 2011-2013 e 2021-2023): nonostante già così il dato evidenziato metta in luce un forte calo d’interesse del pubblico giovanile rispetto al mondo dell’alcol, bisogna comunque tenere in considerazione che si tratta di un risultato fortemente parziale, in quanto è legittimo ipotizzare che la fascia d’età 18-34 sia variamente composta e fortemente eterogenea. I nati fino al 1996, quindi la parte di campione di età che va dai 34 ai 28 anni, sono ancora a pieno titolo millennial; ed è plausibile che abbiano modalità di consumo, e modelli culturali di riferimento, molto diversi rispetto agli intervistati dello stesso segmento di età 27-18. Corollario: attendiamoci ulteriori cali, giacché se venisse realizzato un ulteriore triennio di studio nel 2031-2033 è verosimile che il campione analizzato, composto a quel punto dall’interezza della Gen Z e dai primi neo-adulti della Gen Alpha, restituisca un’immagine della realtà in cui sarà evidente che l’interesse nelle bevande alcoliche abbia subito non una flessione, ma un crollo. Secondo studi Nielsen, infatti (“Gen Z Alcohol Trends”) emerge che il 47% dei soggetti intervistati (statunitensi con più di 21 anni ma nati dopo il 1996) ha dichiarato di “non aver mai provato una bevanda alcolica”, contro il 36% dei millennial a cui è stata posta la stessa domanda.

Perché si sta verificando questo cambiamento nei modelli di consumo? Sicuramente un’accresciuta consapevolezza sui potenziali rischi di salute correlati al consumo di bevande alcoliche ha giocato un ruolo determinante nel modo in cui i più giovani vedono e si relazionano al mondo dell’alcol, ma la risposta non può esaurirsi qui. Ci deve essere dell’altro – un fattore determinante che ha sempre sostenuto il fascino e la magia esercitati dalle bevande alcoliche sul genere umano, e specie sui più giovani, deve essere venuto a mancare: di cosa si tratti è presto detto, l’alcol non è più fico. Non lo è più, oltre che per le motivazioni legate a questioni di salute (rilevanti specie in realtà sociali come appunto quella degli USA, in cui la deriva post-proibizionista, unita ad un’età legale di consumo altissima sfocia in una pressoché totale mancanza di educazione dei giovani alla bevuta, e ad abusi significativi non appena siano permessi), perché l’alcol causa una perdita di freni inibitori troppo pericolosamente collegabile a temi scottanti per le nuove generazioni, specie quelli di natura razziale, sessuale e di genere: se una cosa è difficile da gestire, se può costringere a confrontarsi con parti di sé che si temono, o se può causare ripercussioni negative molto più durature di un gesto avventato compiuto mentre non si era del tutto in sé, allora è meglio evitarla del tutto.
L’alcol non è più fico perché spesso collegato ad ambienti percepiti come non inclusivi: l’immaginario delle bevute di birra nelle confraternite dei college, nei pub fumosi e nei cantieri è stato legato da decenni di colpevole propaganda commerciale (e di colpevoli avventori felici di sguazzare in un ambiente esclusivamente maschile ed eterosessuale) a un mondo machista, sessualizzato e troppo “adulto” (leggi: vecchio). Non basta cambiare vocabolario per diventare magicamente un “patrimonio di tutti”, per la gran parte dei Gen Z-ers ciò che non è inclusivo o non pare esserlo non è tollerabile, figuriamoci cool; e quindi ecco, via l’alcol senza se e senza ma: che si butti via il bambino con l’acqua sporca.

L’alcool non è più fico, poi, perché non è fotogenico: se un tempo ci si innamorava delle parole, delle descrizioni minuziose di Michael Jackson e di Veronelli, e per sapere non potevamo che leggere e leggere; per i nativi digitali mobili tutto questo non esiste più. Ci sono TikTok e Instagram ora, e in video le bitter e le tripel, con quei colori così normali e tutti uguali, non colgono nel segno e non riescono a fermare lo scroll compulsivo e a catturare ‘l’attention span’ ormai ridotta al lumicino. Né bastano le etichette trasgressive o di design, e i colori accesi: i ragazzi della Gen Z vogliono di più. La confezione bella deve esserci ma non è tutto, anche il prodotto deve vedersi, e mostrarsi non solo per quello che di per sé è, ma in modo didascalico e colorato. In un commento ricorsivo a se stesso. La pastry stout colpisce solo se ha letteralmente dentro al bicchiere anche i donut e la spuma gelato, la birra acida alla frutta ha senso quando diventa azzurro cielo o rosa fluo: dove sono altrimenti, se non li vedo a tinte forti, i mirtilli o il lampone millantati nella caption? È l’immagine a raccontare, ma se non viene super-caricata, e si limita a ritrarre il prodotto nella sua nudità di oggetto potabile, allora non racconta abbastanza. Bisogna raffigurare analogicamente tutti i descrittori di degustazione in foto e video per dare un senso al lavoro; o la birra, e il calice di vino, rimarranno “una” birra e “un” calice di vino, persi tra i pixel senz’anima di milioni di birre e vini.
In generale, su questo fronte, si è persa finezza di sensi: se per dirla con Wittgenstein “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, allora il mondo di molti giovani (e meno giovani) è sempre più angusto. Se già quindici anni fa sulle pagine di Repubblica – in uno studio confutato poi da più voci nei numeri, ma la cui veridicità in termini di sostanza può ravvisarsi analizzando qualsiasi testo divulgato sui mezzi di comunicazione – si parlava di “generazione venti parole”, con riferimento ai 20 lemmi che avrebbero composto oltre il 50% dei discorsi scritti e orali effettuati tra teenager; forse adesso la situazione è ancora più soffocante. Iper-stimolati da video di 15 secondi e sottotitoli lampeggianti, da titoli a effetto e parole usate a casaccio o in maniera formulaica finché cessano di avere senso; stiamo perdendo sfumature, capacità di rappresentare concetti astratti, complessità di analisi e di pensiero: anche il mondo della gastronomia risente di questo fenomeno. Un linguaggio impoverito è una capacità di immaginare descrizioni, e di formularne, impoverita; e a parere di chi scrive, di riflesso, necessariamente anche una ridotta abilità nel dare un nome alle proprie sensazioni sensoriali e quindi nell’analizzarle e allenarne la percezione. Abbiamo bisogno di gusti, flavors, odori sempre più sfacciati e monocolore; diventiamo incapaci di chiamare per nome le sottigliezze e quindi di identificarle.

L’alcol, già mutilato nella sua espressione dalla scarsa idoneità alla rappresentazione visiva, esce cambiato anche dal punto di vista sensoriale: sempre secondo Nielsen, i Gen-Zers che consumano alcol prediligono “opzioni flavor forward” e in particolare gli hard seltzer (34% del campione), “acque alcoliche” ai gusti di frutta, erbe o spezie che nella grande maggioranza dei casi non vengono ottenute tramite macerazione o estrazione della materia prima corrispondente, ma attraverso l’aggiunta di aromi. In altre parole, una birra alle ciliegie (con le sue sfumature mandorlate e amaricanti, i terziari di fermentazione, le note di legno date dall’invecchiamento) non sa più abbastanza di ciliegie perché sia degna di attenzione, le si preferisce una bibita alcolica “al gusto di ciliegia”, con annesso estratto di barbabietola per il colore, perché fluorescente, lampeggiante e inequivocabile.
E se sui temi dell’inclusività, di un’educazione ai rischi dell’alcol (ma anche a un consumo consapevole), e della necessità di adottare una comunicazione migliore nonché in generale un atteggiamento diverso nei confronti del mondo sono d’accordo con i ragazzi della Gen Z; su quest’ultimo punto non mi avranno mai: datemi una birra che sa di birra, mi importa poco se pare cringe, lasciatemi parlare per ore dei profumi di melone dei luppoli sloveni di nuova generazione, e gli hard seltzer con le goccine beveteveli pure voi.