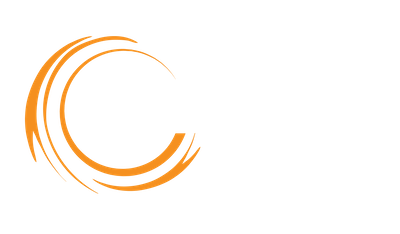L’assaggio analitico: fisiologica, interpretativa e mnemonica

L’esperienza dell’assaggio analitico si sviluppa attraverso attività che possiamo distinguere in: sensoriale-fisiologica, sensoriale-interpretativa e mnemonica. Vediamole in sintesi.

La degustazione consta anzitutto di un’attività sensoriale-fisiologica, che consiste in una raccolta di informazioni effettuata mediante una piattaforma di recettori che ci vengono assegnati in dote dalla nostra stessa fisiologia. Ognuno di noi mette al lavoro i medesimi organi di senso, che operano con i medesimi protocolli di funzionamento. Però esiste anche una fisiologia, che potremmo definire individuale, che interessa le peculiarità, le variabili, in rapporto alle quali ciascuno esercita i protocolli di funzionamento, con differenze, magari rilevanti, che possono essere dettate da alterazioni occasionali (un raffreddore) o permanenti (una sinusite cronica); ma anche dai diversi livelli di sensibilità agli stimoli che ognuno possiede (uno stesso alimento, consumato nello stesso momento, può essere giudicato con intensità gustative differenti).
La seconda tipologia di attività su cui poggia l’esperienza dell’assaggio è quella che possiamo etichettare come sensoriale-interpretativa. Si configura infatti come interpretazione delle informazioni sensoriali che si vanno via via raccogliendo; informazioni (di per sé anonime, consistendo in stimoli: visivi, odorosi, tattili, gustativi) alle quali si deve dare un nome, apporre un’etichetta: “questo vino sa di frutti di bosco”; “questo formaggio sa di erbe di campo”. In questa sfera sono compresenti almeno tre aspetti. Il primo è quello dell’interpretazione associativa: nel “battezzare” una sensazione si fa riferimento a quelle, simili ad essa, già archiviate nella propria banca dati esperienziale. Il secondo aspetto di cui tener conto è quello dell’interpretazione combinativa, meccanismo in base al quale il cervello può, elaborando due sensazioni, descriverle facendone una sintesi. Tipico, nella birra, è il caso – nell’analisi di alcune tipologie statunitensi, come le American Amber o Brown Ale – della “somma” tra le percezioni di caramello (date dai malti di base) e quelle agrumate (date dai luppoli), la cui sovrapposizione evoca sensazioni di chinotto. Infine, terzo aspetto da tener presente nell’ambito dell’attività sensoriale-interpretativa, è quello dell’interpretazione sinestetica: locuzione con cui si sottolinea come il processo di riconoscimento di uno stimolo tenda ad avvalersi di tutte le informazioni e di tutti i supporti a disposizione (naso, bocca, tatto, occhi e magari anche orecchie). Per questo una degustazione alla cieca risulta così impegnativa, perché ad essa viene a mancare l’elemento informativo dell’immagine.
Terza tipologia di attività attraverso la quale si compie l’esercizio della degustazione è quella che indichiamo come mnemonica, in quanto incentrata sui meccanismi del ricordo. In tale ambito, sono due gli aspetti di particolare importanza e meritevoli, quindi, di essere segnalati. Il primo riguarda la memoria individuale: la consistenza, la tenuta in allenamento e l’eventuale accrescimento del proprio database gustolfattivo. Vediamo un esempio. Quando non lo si conosca e prima, perciò, di poter identificarlo come tale, l’aroma del chiodo di garofano (che per il suo potere anestetico è usato, in essenza, nella preparazione di disinfettanti del cavo orale e farmaci odontalgici), può essere, con una certa frequenza statistica, associato appunto a quello di “medicinale”: a una nota odorosa, cioè, con la quale si entra magari più facilmente in contatto, anche da parte di persone non aventi familiarità con le spezie. Tale nota odorosa – quella di un portatore secondario, un “derivato”, rispetto al suo portatore naturale (il chiodo di garofano in sé) – funge allora da ciò che si definisce “mediatore mnemonico”: il descrittore che, nell’orizzonte esperienziale di chi ne fa uso, rappresenta il primo sostituto del descrittore naturale (non utilizzabile in quanto non conosciuto direttamente). Si consideri quanto questo meccanismo della memoria individuale influisca su quello, già visto, dell’interpretazione associativa. Il secondo aspetto rilevante, in ordine all’attività mnemonica, è quello – parallelo alla “individuale” – della memoria collettiva: attiene al patrimonio comunitario delle attitudini alla sensorialità del gusto, con le specificità che emergono da caso a caso. Quelle specificità per cui, ad esempio, le popolazioni occidentali hanno poca familiarità con il gusto umami e molta familiarità con il salato; mentre alle popolazioni orientali accade l’esatto contrario.